08
ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).
"Se uno dichiara
al padre
o alla madre:
«È korbàn!»,
cioè offerta
a Dio, non
gli consentite
di fare più nulla
per il padre
o la madre."
(Marco 7,11-12)
Questa frase enigmatica è inserita all’interno
di una polemica che Gesù sta intessendo
con alcuni farisei e scribi, venuti
da Gerusalemme in Galilea per verificare
e censurare l’insegnamento e il comportamento
del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:
ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano
le norme della purità rituale sancita dalla
tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando
di ipocrisia i suoi contestatori attraverso
un caso concreto, quello appunto del korbàn,
termine aramaico che indica l’“offerta”
sacra destinata da un fedele al tempio.
Il procedimento era semplice: quando un
ebreo dichiarava formalmente che una somma
di denaro o un altro bene era korbàn, cioè
consacrato per il tempio, quella cifra o quella
realtà non era più disponibile per altre finalità,
secondo quanto affermava una prescrizione
della tradizione giudaica presente nella
Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni
che regolavano la prassi dei fedeli
ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate
in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che
aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale
in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.
Gesù presenta una scandalosa applicazione
di questa norma specifica. Se un ebreo
vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento
dei genitori anziani, può decidere di assumere
una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo
korbàn per il tempio, così che non
ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà
libero dall’obbligo filiale. Ovviamente
l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò
ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado
questo voto restava solo formale e, quindi,
fittizio e non comportava una reale donazione,
ma era soltanto un mezzo estrinseco
per evadere quell’obbligo morale.
I maestri, scribi e dottori della Legge, erano
consapevoli dell’immoralità di un simile
comportamento, ma consideravano lo stesso
valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la
perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale
al cuore della Bibbia, lacerando il velo
ipocrita della casistica e proclama il primato
del Comandamento del Decalogo: «Onora
tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove
quell’“onorare” comportava un impegno
operoso di rispetto, di tutela e di sostegno
della vita familiare (si legga sul tema l’intenso
paragrafo di Siracide 3,1-16).
La conclusione che Cristo appone alla sua
polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento
fondamentale della vera religiosità:
«Voi in questo modo annullate la parola di
Dio con la tradizione che avete tramandato
voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta
una norma umana, a un comandamento morale
si sostituisce un precetto legale, alla limpidità
della spiritualità biblica subentra la meschinità
dell’interesse privato, anche se ammantato
di autorizzazioni ufficiali.
Ritorna anche in questo evento della vita di
Gesù l’afflato della fede profetica che impediva
al legalismo e al ritualismo di soffocare
l’anima profonda della religione biblica.
L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia
e carità debbono sempre avere il primato
sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.
Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)
01
ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).
"Tutti mangiarono a sazietà…
Quelli che avevano mangiato
i pani erano cinquemila uomini."
(Marco 6,44)
Questa volta affrontiamo una questione
che potrà sembrare secondaria.
Ci interessiamo dei numeri
nei cui confronti il mondo semitico (ma
non solo) non si comporta con criteri solo
quantitativi, come accade ora a noi, ma
soprattutto qualitativi. Anche chi non ha
una grande assuefazione con la Bibbia sa
che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno
spesso valore simbolico e sono segni
di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,
al riguardo, è emblematica: tra cardinali,
ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!
E tutti citano quel passo in cui si afferma
che «il numero della Bestia è 666» (13,18),
che è multiplo del 6 e somma di multipli
del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”
(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non
dire poi che – secondo l’antica scienza della
“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche
hanno un valore numerico – quel
666 può essere la trascrizione “cifrata” del
nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN
QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +
S 60 + R 200 = 666.
Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto
con l’indicazione dei fruitori della
prima moltiplicazione dei pani secondo
Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo
parallelo, aggiunge: «senza contare le
donne e i bambini» (14,21). Marco per la
seconda moltiplicazione dei pani riduce
il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato
da Matteo (15,38), sempre con la
precisazione riguardante donne e bambini
che nell’antico Vicino Oriente non erano
un soggetto giuridico in senso stretto
e, quindi, non entravano nel computo.
Qualche perplessità nasce su questa folla
enorme, tenendo conto che la Galilea era
una regione limitata e Gesù si fermava a
parlare in piccole rade del lago di Tiberiade
o su prati molto ristretti con gruppi locali
abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista
parla di una suddivisione «in gruppi
di 100 e 50» persone (6,40).
Effettivamente bisogna notare che il
numero 1.000 era spesso adottato per
designare semplicemente una grande
quantità difficile da contare, oppure acquistava
il valore simbolico dell’immensità
e persino dell’infinito: Dio, ad esempio
perdona e ama per «mille generazioni»
(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo
della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di
persone. Tra l’altro, è curioso notare che
il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica
anche il “bue” che potrebbe essere
l’unità di misura alimentare per un gruppo
clanico o familiare esteso, come lo era
allora la famiglia patriarcale.
Certo, in alcuni casi siamo in presenza
di numeri reali o almeno legati a dati
documentari, come accade nei censimenti
di Israele nel deserto che aprono
il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,
riflettono cifre del periodo in cui il popolo
ebraico era stanziato nella terra promessa,
con probabili ritocchi simbolici, soprattutto
quando si parla delle «migliaia
di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),
designazione riservata ai vari clan. Reali
sono, in buona parte, i dati numerici allegati
dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi
in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati
da Babilonia. È, però, indubbio che la
trasmissione stessa di simili dati nei vari
codici biblici a noi giunti ha subìto spesso
variazioni e incertezze.
Rimane, comunque, fermo il primato
simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il
caso – nel racconto della moltiplicazione
dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo
caso, come i dodici apostoli o le tribù
ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni
della terra di Canaan (Atti 13,19) o i
sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana
(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e
l’abbondanza sono tipiche del banchetto
messianico.
Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)
24
set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.
"Aveva dimora fra le
tombe e nessuno riusciva
a tenerlo legato, neanche
con catene... spezzava
le catene e spaccava
i ceppi e nessuno
riusciva a domarlo".
(Marco 5,3-4)
Siamo – stando al racconto di Marco
(5,1-20) – sulla costa orientale
del lago di Tiberiade «nella regione
dei Geraseni» (Matteo parla, invece,
di Gadara, a sud-est dello stesso lago).
Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza
pagana e quindi “impura”. Ecco
emergere questa figura terribile, una
sorta di mostro che vive o in una necropoli,
tra i morti, oppure sui monti desertici
delle alture del Golan. Appare, così,
un altro segno di “impurità” e negatività,
la morte e il deserto. Quando Gesù
interpella lo “spirito impuro” che travolge
quest’uomo, costui risponde: «Mi
chiamo Legione», un altro elemento negativo
perché rimanda all’oppressione
romana e al suo esercito.
Ma non è finita. Quando Gesù decide
di liberare quest’uomo dagli “spiriti
impuri”, essi domandano e ottengono
di entrare in una mandria di porci
là allevati, tipici animali “impuri” per
la tradizione giudaica. A quel punto il
branco «si precipita dal burrone nel
mare, affogando uno dopo l’altro nel
mare». Il mare (in questo caso il lago:
il linguaggio biblico denomina con un
unico termine le grandi distese d’acqua)
è il simbolo del caos e del male.
La sequenza negativa che regge le fila
del racconto è, dunque, impressionante:
Decapoli, pagani, sepolcri, monti
desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,
porci, mare.
Sembra, quindi, di essere in presenza
di una sorta di compendio del male
del mondo, del demoniaco che avvelena
la storia ma anche dell’idolatria,
perché Isaia descrive così gli idolatri:
«Abitano nei sepolcri, passano la notte
in nascondigli, mangiano carne suina e
cibi impuri... bruciano incenso sui morti
e sui colli insultano il Signore»
(65,4.7). Qual è, allora, il significato da
assegnare a questa narrazione, sia nella
sua realtà storica sia nel suo valore
esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto
dall’evangelista, di quello sventurato,
lo delinea come un pazzo furioso:
non si può legarlo perché reagisce brutalmente,
è autolesionista perché si percuote
con pietre, urla in modo sconclusionato
giorno e notte. Una volta sanato
da Gesù è, invece, tratteggiato come
«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).
Fin qui per quanto riguarda l’evento
storico, ossia la guarigione di un malato
mentale, così come Gesù sanerà un
ragazzo epilettico, scendendo dal monte
della Trasfigurazione (9,14-29). Ma
qual è il valore ulteriore che l’evangelista
assegna a questo fatto? La risposta
deve tener conto proprio di tutti gli elementi
negativi che abbiamo prima elencato
e dell’antica convinzione di Israele,
secondo cui le sindromi più gravi
presupponevano una colpa personale
o una possessione demoniaca. La vicenda,
allora, diventa una narrazione
esemplare per celebrare la vittoria di
Cristo sul male in tutte le sue forme:
egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio
del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle
forze oscure, sia fisiche sia morali, che
tormentano la storia umana.
Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)
17
set
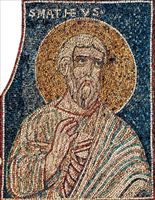
San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.
"Per quelli che
sono fuori tutto
avvienein parabole
affinchéguardino, sì,
ma non vedano,
ascoltino, sì, ma non
comprendano..."
(Marco 4,11-12)
«Così che non si convertano e
venga loro perdonato!»: finisce
con questa fosca clausola
la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo
di Marco riguardo alla funzione delle
parabole che egli sta raccontando. Paradossale
è proprio questa definizione
della finalità delle parabole, espressa
con quell’“affinché” che indica appunto
uno scopo da raggiungere. Forse che
Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,
che è anche il suo modo più comune
di insegnare, per offuscare la
mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli
la conversione («così che non si
convertano») e il relativo perdono dei
peccati («e non venga loro perdonato»)?
La frase, in verità, si basa su una citazione
del profeta Isaia che, nel giorno della
sua vocazione, aveva ricevuto questo
monito: «Rendi insensibile il cuore di
questo popolo, rendilo duro d’orecchi e
acceca i loro occhi, e non veda con gli
occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda
col cuore, né si converta così da
essere guarito!» (6,10).
Dobbiamo proprio partire da questa
citazione per comprendere le dure parole
di Cristo che sembrerebbero smentire
la finalità salvifica della sua predicazione.
È chiaro il contenuto dell’appello rivolto
a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto
degli Israeliti, un fenomeno scontato
e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi
sono in realtà equivalenti a indicativi:
si adotta questa forma per
mostrare quale sarà il risultato della
predicazione profetica, che Dio certamente
non vuole, ma che gli è già nota
ed è inserita nel suo disegno di salvezza.
Questo progetto salvifico, però, continuerà
lo stesso e si attuerà giudicando il peccato
e l’indurimento del cuore e salvando
chi si convertirà e compirà il bene.
L’imperativo non è, quindi, un invito
a operare in quella linea negativa, bensì
è un modo per rappresentare in forma
efficace che neanche il male sfugge
al piano divino, che non esiste una divinità
negativa che si oppone all’unico Signore,
come insegnava il dualismo religioso
(Dio del bene contro il dio del male),
che la libertà umana con le sue scelte
perverse non è ignota al Creatore e
non frustra la sua volontà di salvezza.
Nello stesso libro di Isaia si giunge al
punto di porre anche il male sotto il comando
divino: «Sono io che formo la luce
e le tenebre, faccio il bene e provoco
il male» (45,7). Con questa frase così
aspra si vuole soltanto ricordare che
nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;
anche il male e il peccato possono
essere inquadrati nel suo grande disegno
sull’essere e sull’esistere.
Gesù cita, dunque, questa tesi importante
formulata nello scritto isaiano e
quella “finalità” («affinché...») è di tipo
“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale
espressione «affinché si adempia
la Scrittura che dice...». L’evangelista
ne condivide con Gesù (che rimanda
a Isaia) il contenuto: le parabole,
che dovrebbero essere un luminoso
esempio di rivelazione, diventano un
elemento di ostinazione contro Cristo.
Questo, però, non deve impressionare,
perché Dio – che sa anche dal male trarre
un bene – continuerà lo stesso a compiere
l’insediamento del suo Regno.
È interessante vedere come Matteo
abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù
sostituendo alla finale («affinché...»)
una causale più immediata e chiara
(«perché...»). Il messaggio in parabole di
Gesù non è accolto «perché il cuore di
questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri d’orecchi, hanno
chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).
Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)
10
set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.
"Nella sinagoga
vi era un uomo
posseduto da uno
spirito impuro.
Cominciò
a gridare:
«Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno?
Io so chi tu sei:
il Santo di Dio!»"
(Marco 1,23-24)
Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:
nell’arco di un giorno e nello
spazio di questa cittadina che s’affaccia
sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie
di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge
nella sinagoga locale (quella che Giovanni
inserì come fondale per il celebre discorso
di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso
una persona si alza nell’assemblea, mentre
Gesù sta insegnando con grande autorità, e
gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo
(Marco 1,21-26). Chi travolge
quest’uomo apparentemente normale, facendone
un avversario di Cristo?
In lui agisce un’inattesa presenza specifica,
sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È
una presenza vitale e personale che interloquisce
con Cristo, paradossalmente riconoscendolo
come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come
dotata di una trascendenza e di un’origine
divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il
quale sa di avere come avversario Dio stesso,
presente e operante in Gesù Cristo. Non
possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione
da una malattia grave, come la demenza (Marco
5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito
considereremo e rubricati dagli evangelisti
come possessioni diaboliche.
Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino
Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna
del demoniaco tutto il negativo della storia:
le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli
influssi sociali nefasti, il peccato personale, il
male in generale. Qui, invece, si ha una presenza
personale specifica; è l’incontro con un
essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi
suo avversario; con lui Gesù ingaggia
un duello che si risolve con un comando
efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».
E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido
di sconfitta di Satana. La salvezza non viene
da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni
magiche, ma solo da un ordine autorevole
e operativo di Cristo.
Al centro di questo racconto non c’è, quindi,
lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore
dal male. Il cristianesimo rigetta ogni
forma di dualismo che veda come arbitri della
storia e dell’essere due divinità antitetiche: il
demonio non è il principio del male che combatte
il principio divino del bene. Satana (in
ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è
da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,
la sua presenza dev’essere ridimensionata,
il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un
essere personale che agisce con forza. Certo,
l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,
perché si tratta di un concetto positivo,
usato anche per Dio (ad esempio, le tre
“persone” della Trinità).
Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale
l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi
anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe
essere segno di intimità, di donazione, di
amore. Lo scrittore francese agnostico André
Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:
Io sono colui che non sono». E curiosamente
lo stesso autore concludeva: «Non credo nel
diavolo; ma è proprio quello che il diavolo
spera: che non si creda in lui». A lui farà eco
Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima
astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce
della sua morte».
Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)
24
nov

Riposo dei cavatori di Baccio Maria Bacci (1888-1974). Firenze, Galleria d'arte moderna.
" Vegliate!
Non sapete
quando il padrone
di casa ritornerà:
se a sera
o a mezzanotte.
Giungendo
all'improvviso,
non vi trovi
addormentati! "
(Marco 13,35-36)
Lunga più del giorno sembra la notte, con le sue tenebre. Lo sa bene il sofferente insonne, come confessa Giobbe: «Notti di ansia mi sono ormai riservate. Se mi corico, dico: Quando è ora di alzarsi? La notte è sempre più lunga e io sono stanco di rigirarmi fino all’alba» (7,3-4). Isaia, come è noto, ha “sceneggiato” dal vivo questa estensione soffocante attraverso il dialogo di due sentinelle: «Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? L’altra sentinella risponde: Viene il mattino, ma poi ancora la notte... » (21,11-12). Per questo era invalso l’uso di dividere l’arco della notte in “veglie”, in pratica in turni di guardia.
Gli Ebrei ne contavano tre di quattro ore ciascuna. Marco, invece, nel frammento dall’atmosfera molto tesa che abbiamo proposto, adotta il sistema di computo in vigore presso i Romani. Essi suddividevano la notte in quattro “veglie” di tre ore: si iniziava con la «sera», in greco opsé, a cui subentrava la «mezzanotte» (mesonýktion); si sentiva poi il «canto del gallo» (alektorofonía) ed ecco, infine, l’alba, il proí. Gesù, però, introduce su questa sequenza temporale un bozzetto narrativo. Siamo in un palazzo, il padrone è andato lontano, ma ormai è sulla via del ritorno. Ignota e imprevedibile è la durata della “veglia” notturna al termine della quale il signore si presenterà al portone. I servi devono, quindi, “vegliare”.
Questo verbo ricorre in apertura alla scenetta: «Vegliate», in greco gregoréite! E ritorna anche nell’appello-applicazione finale che Gesù fa al quadretto delineato: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: gregoréite, vegliate! » (13,37). Appare, così, una dimensione significativa della predicazione di Gesù, quella dell’urgenza per una scelta da compiere: «Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo» (Matteo 24,44). Spesso nella predicazione attorno a questo passo evangelico si fa riferimento alla morte, che è un ospite che non s’annuncia. In realtà, Gesù rimanda al suo passaggio che avviene nella storia e nel presente e che esige una decisione netta. Potremmo evocare un’altra mirabile scenetta, quella dipinta dall’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3,20).
In questa luce si intuisce come il sonno sia il segno dell’indifferenza, anzi, del rifiuto di un impegno serio e operoso. Se è vero che la tenebra è simbolo del male e del peccato, è evidente che chi si adagia nel suo grembo facendosi accogliere e cullare diventa «figlio delle tenebre», cioè succube dell’empietà e dell’immoralità. Continuerà san Paolo, commentando idealmente le parole di Cristo: «Voi, però, non siete nelle tenebre... perché siete figli della luce e del giorno. Noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo, allora, come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri!» (1Tessalonicesi 5,4-6).
Ma l’Apostolo è convinto di una necessità che vale anche per i cristiani che si lasciano lambire dal torpore: «È ormai tempo di svegliarsi dal sonno, perché adesso la salvezza è vicina... La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce!» (Romani 13,11-12).
Pubblicato il 24 novembre 2011 - Commenti (1)
|
|