05
gen
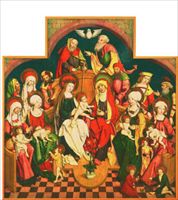
Genealogia Sacra. Germania, 1500 ca. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art. Olio su pannello, cm 158,7x150,5. John G. Johnson Collection.
"In principio era
il Logos
e il Logos era
presso Dio
e il Logos
era Dio...
E il Logos carne
divenne
e pose la sua
tenda in mezzo
a noi".
(Giovanni 1, 1.14)
Abbiamo lasciato intenzionalmente la
parola greca del testo originario nel celebre
passo biblico che proponiamo ai
nostri lettori.
Logos significa “parola, verbo,
discorso”, indica la comunicazione tipica
dell’essere umano. Nella Bibbia, però, come
ben sappiamo, la “parola” è qualcosa di più
di quello che intendiamo noi occidentali: essa
è anche l’azione con cui esprimiamo noi
stessi, perciò il termine ebraico dabar designa
contemporaneamente la parola e l’atto.
Non per nulla, nelle prime righe della Sacra
Scrittura, leggiamo: «Dio disse: Sia la luce! E
la luce fu» (Genesi 1,3). La parola divina esprime
la persona stessa e l’opera del Creatore.
In questa luce è arduo tradurre quel Logos
che apre il prologo innico del Vangelo di Giovanni.
Goethe, il famoso poeta tedesco, nel
suo Faust fa tentare al protagonista diverse
versioni che cerchino di esprimere le varie iridescenze
di quel vocabolo greco: in tedesco,
certo, è Wort, ossia “parola”, ma è anche Sinn,
“significato” dell’essere e dell’esistere; è Kraft,
“potenza” efficace e creatrice; e alla fine è Tat,
cioè “atto”, evento pieno e perfetto, anzi persona
in Cristo.
L’Evangelista, quindi, tratteggia il
mistero divino, glorioso e trascendente del Figlio
di Dio che è «presso Dio ed è Dio».
C’è, però, una svolta radicale che si manifesta
in un incrocio tra due realtà che la cultura
greca vedeva in opposizione, quasi in collisione
tra loro, così da essere reciprocamente
repellenti. Il Logos diventa sarx, “carne”.
Ora, quest’altro termine greco definisce la fragilità
della creatura, il suo essere finita, caduca,
mortale, legata al tempo e allo spazio.
Ecco,
allora, quello che potremmo chiamare lo
scandalo dell’Incarnazione. Il Logos divino,
perfetto, infinito ed eterno diventa sarx, la
“carne” umana, limitata, votata alla sequenza
temporale, imprigionata nello spazio. Gesù,
il Figlio di Dio, sarà appunto vincolato a
una cultura, a una lingua, a un modo di vivere
sociale, a un territorio e a un’epoca storica
circoscritta. La sua realtà profonda di Logos
divino è quasi compressa e umiliata fino
all’esperienza della morte, che è per eccellenza
la nostra carta d’identità di creature racchiuse
in un perimetro di tempo e spazio.
È ciò che esprimeva san Paolo in un inno
incastonato nella Lettera ai Filippesi: «Cristo
Gesù, pur essendo di natura divina..., svuotò
sé stesso, assumendo la condizione di
servo, divenendo come gli uomini e presentandosi
in forma umana; umiliò sé stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla
morte di croce» (2,6-8). Ed è ciò che a suo modo
ha cantato anche uno scrittore agnostico
come l’argentino Jorge Luis Borges in una
sua poesia pubblicata nel 1969 e intitolata appunto
Giovanni 1,14: «Io che sono l’È, il Fu e
il Sarà / accondiscendo al linguaggio / che è
tempo successivo... / Vissi prigioniero di un
corpo e di un’umile anima. / Appresi la veglia,
il sonno, i sogni, / l’ignoranza, la carne, /
i tardi labirinti della mente, l’amicizia degli
uomini / e la misteriosa dedizione dei cani. /
Fui amato, compreso, esaltato e appeso a
una croce». Un antico testo apocrifo cristiano
metteva in bocca a Gesù queste parole: «Io, il
Signore, divenni piccolo per potervi ricondurre
in alto, donde siete caduti».
Pubblicato il 05 gennaio 2012 - Commenti (2)
22
dic

L’adorazione dei Magi, lastra marmorea della tomba di Severa (300 ca.) dalle catacombe di Priscilla a Roma. Vaticano, Museo Pio Cristiano.
"Lo vedo,
ma non ora;
lo contemplo,
ma da lontano:
una stella spunta
da Giacobbe,
uno scettro sorge
da Israele".
(Numeri 24,17)
In un mondo in cui la magia raccoglieva sotto il suo manto molteplici espressioni spirituali, culturali e folcloristiche, la figura del mago Balaam – del quale si hanno tracce anche in testimonianze extrabibliche – aveva un rilievo particolare. Assegnato dal racconto del libro dei Numeri ora al popolo degli Aramei, ora a quello degli Ammoniti, Balaam incrocia la vicenda di Israele in marcia verso la terra promessa, dopo aver lasciato alle spalle l’oppressione egiziana. Questa massa di fuorusciti ha ormai raggiunto le steppe di Moab in Transgiordania. Battaglieri e pronti a tutto, accompagnati dalla fama di popolo protetto da un Dio potente, gli Israeliti seminano il panico tra gli indigeni moabiti e ammoniti.
Costoro decidono di ricorrere non tanto alle armi quanto piuttosto alla magia, e il re Balak di Moab interpella appunto Balaam perché, con le sue efficaci maledizioni, riesca ad arrestare questa orda di invasori. Ma ecco la grande sorpresa: con tutta la sua buona volontà, il mago non riesce a emettere se non benedizioni, divenendo paradossalmente un “profeta” di Israele, malgrado sé stesso, il suo desiderio e l’attesa del suo committente, il sovrano moabita. Il racconto dei capitoli 22-24 del libro dei Numeri è vivacissimo e, data la sua arcaicità, rivela anche qualche spunto favolistico, come quello dell’asina parlante la quale si schiera, anch’essa, dalla parte degli Ebrei (22,22-35).
Affidiamo ai nostri lettori l’impegno di seguire integralmente quella narrazione, soffermandosi soprattutto sui quattro oracoli di benedizione che Balaam pronunzia, in luogo delle attese maledizioni (23,7-10; 23,18-24; 24,3-9; 24,15-24). Nell’ultimo oracolo incontriamo il passo che proponiamo ora, un testo divenuto celebre per la rilettura messianica che ha subito nel giudaismo. Lo sguardo del mago-profeta si allunga verso un futuro ancora nebuloso e lontano e là egli intravede due segni, una stella e uno scettro, simboli regali.
La stella mattutina “Lucifero” era lo stemma ideale del re di Babilonia (Isaia 14,12). Ecco che la traduzione antica del nostro frammento ebraico nella lingua più popolare in epoca successiva, cioè l’aramaico, ha questa resa della prima immagine: «Un re spunta da Giacobbe». La stella si è trasformata in un sovrano, il re Messia. Così accadrà per Cristo, svelato ai Magi (ideali colleghi di Balaam) da una stella, e definito nell’Apocalisse «stella radiosa del mattino» (22,16). La luce, simbolo divino, accompagnerà anche il canto messianico di Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (9,1).
Più immediato è il valore simbolico dello scettro, segno dell’autorità regale. Ma anche qui l’antica versione aramaica, riflettendo la tradizione giudaica, traduce invece di “scettro”: «Un messia sorge da Israele». Era ciò che balenava già nella benedizione che il patriarca Giacobbe aveva riservato alla tribù di Giuda dalla quale sarebbe nato Davide e, quindi, il re messianico: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli» (Genesi 49,10). Abbiamo, così, nelle parole di quel remoto mago d’Oriente un bagliore che anche i cristiani leggono, come gli Ebrei, quasi fosse il ritratto del Messia. Solo che per i cristiani quella stella e quello scettro rimandano a una persona precisa, Gesù Cristo, figlio di Maria, figlio di Dio.
Pubblicato il 22 dicembre 2011 - Commenti (2)
15
dic

Presentazione al tempio di Pietro Cavallini (1240 C.-1320 C.), Storie di Maria. Roma, Santa Maria in Trastevere.
"Egli è qui
per la caduta
e la risurrezione
di molti in Israele,
come segno
di contraddizione!
Anche a te
una spada
trapasserà
l'anima".
(Luca 2,34-35)
Un grande romanziere vittoriano inglese, Anthony Trollope (1815-1882), pone sulle labbra di un prete, mister Harding, protagonista dell’opera Il custode, le parole di Simeone, «uomo giusto e timorato di Dio», dopo aver capito che, vecchio e invalido, non potrà più suonare l’amato violoncello. Infatti, ne tocca le corde, ma riesce solo a trarne «un lagno bassissimo, di breve durata, a intervalli». Allora, «con un dolce sorriso» intona quel canto: «Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace!». In realtà, l’inno di Simeone, divenuto il noto Nunc dimittis del latino della liturgia serale della Compieta, non è un addio crepuscolare e malinconico, bensì un saluto festoso all’alba messianica che sta per schiudersi proprio in quel bambino che egli reca tra le braccia.
La scena è negli occhi di tutti, anche attraverso le mille riprese dell’arte nei secoli. Simeone è là, nel tempio di Sion, come una presenza orante. Egli incarna la speranza messianica dell’Israele fedele ed è lo Spirito profetico a muoverlo verso quella modesta famigliola che è salita al santuario per adempiere alla legge biblica del riscatto del primogenito, consacrato al Signore secondo la norma codificata nel capitolo 13 del libro dell’Esodo. Le sue sono innanzitutto parole di lode e di benedizione a Dio per la felicità che gli ha concesso di poter accogliere il Messia: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace... perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza » (Luca 2,29-30).
Ma subito dopo, sempre nello Spirito dei profeti, la sua voce si fa severa e si proietta verso la distesa della storia futura in un oracolo di giudizio e di salvezza. Quel bambino entrerà nell’umanità come un «segno di contraddizione », una sorta di spada – come dirà lo stesso Gesù (Luca 12,51) – che taglia di netto il flusso degli eventi e genera opposizione e persino il rigetto aggressivo. Anche se enfatica, com’era nel suo stile, è suggestiva la definizione che di Cristo ha formulato lo scrittore Giovanni Papini: «il più grande Rovesciatore, il supremo Paradossista, il Capovolgitore radicale e senza paura». L’umanità non potrà evitarne il confronto, per amarlo o per detestarlo. Ininterrottamente saremo costretti a rispondere a quella sua domanda: «Ma voi chi dite che io sia?» (Matteo 16,15).
L’oracolo di Simeone contiene, però, un altro messaggio indirizzato alla madre di Gesù. L’immagine della spada che trafigge l’anima di Maria è parallela alla lancia che trapassa il costato di suo Figlio crocifisso e darà origine alla popolare iconografia della Vergine addolorata col cuore trafitto da una o sette spade. Ma qual è il significato di quell’annunzio terribile? Anticamente alcuni scrittori cristiani, come Origene, pensavano alla spina della tentazione che si incuneava nella fede pura di Maria, di fronte alla croce: si ripeteva per lei la prova di Satana nei riguardi di Cristo. Altri giungevano al punto di ipotizzare anche per lei il martirio! In realtà, il senso è limpido ed è proprio nella stessa linea dell’annuncio rivolto al suo Bambino.
La madre sarà nel cuore della lotta pro e contro Cristo. Anche lei si troverà al centro di quella “contraddizione” ove si scontreranno i cuori. San Paolo è illuminante quando definisce la croce di Gesù come «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma anche potenza di Dio e sua sapienza per coloro che sono chiamati, Giudei e Greci» (1Corinzi 1,23-24). Maria sarà accanto al Figlio anche in quel momento supremo in cui, perdendolo nella morte, lo ritroverà nella Chiesa, corpo del Cristo glorioso, di cui diverrà madre.
Pubblicato il 15 dicembre 2011 - Commenti (3)
08
dic

Pentecoste, dal Lezionario del Vangelo e delle Epistole (Lezionario di St. Trond, Belgio), metà del XII secolo. New York, The Pierpont Morgan Library.
"Effonderò su ogni persona il mio Spirito:
diverranno profeti i vostri figli e figlie,
i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni,
su schiavi e schiave effonderò
il mio Spirito".
(Gioele 3,1-2)
Potremmo idealmente appendere questo testo al centro di un filo che ha due estremi. Il primo è retto da un picchetto piantato nel deserto del Sinai e reca questa dichiarazione- auspicio di Mosè: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!» (Numeri 11,29). Era la reazione della grande guida di Israele all’impulsiva richiesta del giovane Giosuè, il suo futuro successore, che esigeva una censura nei confronti di due ebrei che non erano nella lista dei settanta anziani, il senato costituito da Mosè e investito dallo spirito profetico: anche su quei due, però, «si era posato lo spirito del Signore» (11,26).
L’altro estremo è, invece, legato a Gerusalemme. È il giorno di Pentecoste e l’apostolo Pietro ha davanti a sé la folla che l’ascolta e che è attraversata dallo Spirito Santo, capace di unire tutti nella stessa fede nonostante la diversità delle origini e la differenza delle lingue. Pietro inizia un discorso e spontaneamente applica subito all’evento l’antico oracolo di Gioele (Atti 2,14-21). Di questo profeta si conosce ben poco e la sua collocazione cronologica per la maggior parte degli studiosi è nel periodo successivo all’esilio babilonese, forse nel V secolo a. C. Il suo libretto è nettamente diviso in due quadri, così da diventare un dittico.
La prima scena è occupata da un’invasione di cavallette, simile a un esercito assalitore, flagello endemico dell’agricoltura del Vicino Oriente, presagio di carestia a causa della loro famelica voracità nei confronti delle coltivazioni. Il popolo si affida, allora, al Signore perché, come Sovrano del creato, fermi questa piaga (capitoli 1-2). Il secondo quadro, che occupa i capitoli 3-4, è invece dipinto con colori apocalittici e con lo sguardo puntato verso il «giorno del Signore», il tempo del giudizio finale sul male e sull’iniquità, ma anche aurora di una nuova èra. Sull’umanità, allora, si stenderà lo Spirito divino quasi come un nuovo soffio vitale che attraverserà l’intero popolo, raffigurato in tutte le sue articolazioni generazionali (padri e figli) e sociali (anziani, giovani e schiavi). È una trasfigurazione radicale della comunità che diventa un popolo di profeti, cioè di testimoni della parola di Dio al mondo. È ciò che si proclama anche per i battezzati cristiani nella celebrazione del sacramento che li consacra re, sacerdoti e profeti. È quella trasformazione interiore che aveva cantato il profeta Ezechiele: «Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne» (11,19)
Un’ultima annotazione. Per descrivere lo spirito profetico Gioele usa due segni per noi forse sorprendenti e passibili di equivoco: «i sogni e le visioni». Ora, questo è un simbolo per indicare un tipo di conoscenza – quello appunto mistico, della profezia e della fede – differente dalla nostra logica puramente razionale, un po’ come accade in sogno. Era stato Dio stesso a dichiarare: «Se ci sarà tra voi un profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò a lui» (Numeri 12,6). Per questo il profeta era chiamato anche «Veggente », perché il suo occhio spirituale penetrava nel mistero divino con uno sguardo nuovo e diverso rispetto alla semplice contemplazione della realtà esteriore.
Pubblicato il 08 dicembre 2011 - Commenti (2)
01
dic

Giudizio Universale, angelo con tromba, scuola cassinese. Capua, Sant’Angelo in Formis
" Il Signore,
alla voce
dell'arcangelo
e al suono della
tromba di Dio,
discenderà
dal cielo.
E prima
risorgeranno
i morti in Cristo
e quindi noi,
ancora vivi,
saremo rapiti
con loro..."
(1 Tessalonicesi 4,16-17)
Ora è la seconda città della Grecia, importante
nodo stradale e commerciale,
ricca di monumenti bizantini. Allora
era la capitale della Macedonia e san Paolo
ricordava con piacere l’accoglienza fraterna
che gli avevano riservato i pagani, ma con
amarezza anche la dura reazione degli Ebrei
là residenti, che avevano contro di lui ordito
una sommossa popolare costringendolo a
una fuga indecorosa (Atti 17,1-10). Il fedele
discepolo Timoteo aveva poi recato all’Apostolo,
che si trovava a Corinto, notizie della
neonata Chiesa tessalonicese e dei suoi primi
problemi. Paolo aveva deciso, allora, di inviare
un messaggio a quella comunità, «da leggersi
a tutti i fratelli».
È l’anno 51: è questo il primo scritto paolino
a noi giunto e quasi certamente il primo
testo (cronologicamente parlando) del Nuovo
Testamento. A chi vorrà leggerlo integralmente
verranno incontro tonalità differenti.
C’è il registro autobiografico dei ricordi, segnato
dalla nostalgia, aperto però alla speranza
di un nuovo incontro. C’è il filone teologico
che si sviluppa attorno a tre temi:
l’amore fraterno, il mistero pasquale di Cristo
e la sua parousía o ritorno finale a suggello
della storia. C’è, poi, anche il tema morale
e pastorale: l’Apostolo, in 5,12-28, esorta la
comunità a vivere un’esistenza cristiana perfetta
e pura e lo fa attraverso una sequenza
di quattordici imperativi.
Il nostro frammento testuale si innesta
nel filone teologico, affrontando il tema del
ritorno di Cristo alla fine della storia. Lo scenario
che san Paolo tratteggia è, però, modulato
sul linguaggio apocalittico a quel
tempo dominante che ricorreva a immagini,
metafore e simboli. Così, stando sul vago,
cerca di risolvere un quesito che rodeva l’anima
dei cristiani tessalonicesi, convinti che
quell’ultimo evento fosse imminente. Essi
domandavano: in quell’istante supremo in
cui risorgeranno coloro che sono morti in pace
e in comunione con Cristo, i cristiani ancora
vivi quale sorte avranno?
L’Apostolo ricalca l’apparato delle visioni
epifaniche apocalittiche: cori celesti, trombe
divine, vortici, nubi, cieli squarciati. Non è,
quindi, una descrizione puntuale, ma una
rappresentazione simbolica di quel passaggio
dal tempo all’eterno, dallo spazio terreno
all’infinito di Dio. I morti e gli ancora viventi
entreranno nell’orizzonte trascendente:
ai Corinzi, poi, dirà che «non tutti dovremo
morire [in quel momento estremo], tutti
però saremo trasformati» (1Corinzi 15,51).
Soddisfatta questa curiosità dei Tessalonicesi,
ciò che a Paolo preme è ribadire che il destino
di tutti i fedeli è quello di «andare incontro
al Signore... e così essere per sempre
con lui» (4,17).
Per completezza dobbiamo, però, aggiungere
una nota conclusiva. Contro l’eccitazione
di coloro che, convinti dell’imminenza di
quel momento ultimo, abbandonavano le loro
responsabilità e i quotidiani impegni terreni,
Paolo raccomanda di «fare tutto il possibile
per vivere in pace, occupandosi delle
proprie cose e lavorando con le proprie mani,
come vi abbiamo ordinato, conducendo
una vita decorosa di fronte agli estranei [i
non credenti], senza aver bisogno di nessuno
» (4,11-12). In passato abbiamo già avuto
occasione di registrare come questo appello
sia andato a vuoto, perché – nella Seconda
Lettera che egli indirizzerà ai cristiani di Tessalonica
– l’Apostolo sarà costretto a rivolgere
loro una tirata d’orecchi ricordando che
«chi non vuole lavorare, neppure mangi!» (si
legga 2Tessalonicesi 3,6-15).
Pubblicato il 01 dicembre 2011 - Commenti (2)
24
nov

Riposo dei cavatori di Baccio Maria Bacci (1888-1974). Firenze, Galleria d'arte moderna.
" Vegliate!
Non sapete
quando il padrone
di casa ritornerà:
se a sera
o a mezzanotte.
Giungendo
all'improvviso,
non vi trovi
addormentati! "
(Marco 13,35-36)
Lunga più del giorno sembra la notte, con le sue tenebre. Lo sa bene il sofferente insonne, come confessa Giobbe: «Notti di ansia mi sono ormai riservate. Se mi corico, dico: Quando è ora di alzarsi? La notte è sempre più lunga e io sono stanco di rigirarmi fino all’alba» (7,3-4). Isaia, come è noto, ha “sceneggiato” dal vivo questa estensione soffocante attraverso il dialogo di due sentinelle: «Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? L’altra sentinella risponde: Viene il mattino, ma poi ancora la notte... » (21,11-12). Per questo era invalso l’uso di dividere l’arco della notte in “veglie”, in pratica in turni di guardia.
Gli Ebrei ne contavano tre di quattro ore ciascuna. Marco, invece, nel frammento dall’atmosfera molto tesa che abbiamo proposto, adotta il sistema di computo in vigore presso i Romani. Essi suddividevano la notte in quattro “veglie” di tre ore: si iniziava con la «sera», in greco opsé, a cui subentrava la «mezzanotte» (mesonýktion); si sentiva poi il «canto del gallo» (alektorofonía) ed ecco, infine, l’alba, il proí. Gesù, però, introduce su questa sequenza temporale un bozzetto narrativo. Siamo in un palazzo, il padrone è andato lontano, ma ormai è sulla via del ritorno. Ignota e imprevedibile è la durata della “veglia” notturna al termine della quale il signore si presenterà al portone. I servi devono, quindi, “vegliare”.
Questo verbo ricorre in apertura alla scenetta: «Vegliate», in greco gregoréite! E ritorna anche nell’appello-applicazione finale che Gesù fa al quadretto delineato: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: gregoréite, vegliate! » (13,37). Appare, così, una dimensione significativa della predicazione di Gesù, quella dell’urgenza per una scelta da compiere: «Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo» (Matteo 24,44). Spesso nella predicazione attorno a questo passo evangelico si fa riferimento alla morte, che è un ospite che non s’annuncia. In realtà, Gesù rimanda al suo passaggio che avviene nella storia e nel presente e che esige una decisione netta. Potremmo evocare un’altra mirabile scenetta, quella dipinta dall’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3,20).
In questa luce si intuisce come il sonno sia il segno dell’indifferenza, anzi, del rifiuto di un impegno serio e operoso. Se è vero che la tenebra è simbolo del male e del peccato, è evidente che chi si adagia nel suo grembo facendosi accogliere e cullare diventa «figlio delle tenebre», cioè succube dell’empietà e dell’immoralità. Continuerà san Paolo, commentando idealmente le parole di Cristo: «Voi, però, non siete nelle tenebre... perché siete figli della luce e del giorno. Noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo, allora, come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri!» (1Tessalonicesi 5,4-6).
Ma l’Apostolo è convinto di una necessità che vale anche per i cristiani che si lasciano lambire dal torpore: «È ormai tempo di svegliarsi dal sonno, perché adesso la salvezza è vicina... La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce!» (Romani 13,11-12).
Pubblicato il 24 novembre 2011 - Commenti (1)
17
nov

Duccio di Buoninsegna (1260 ca.-1318), Maestà, cimasa, apparizione sul monte di Galilea. Siena, Museo dell’Opera Metropolitana
" Andate e fate
discepoli tutti
i popoli...
Ecco, io sono con
voi tutti i giorni,
sino alla fine
del mondo "
(Matteo 28,19-20)
Sono, queste, le ultime delle 18.278 parole
greche di cui si compone il Vangelo di
Matteo, gli ultimi dei suoi 1.070 versetti,
nell’ultimo dei 28 capitoli. In quell’«io sono
con voi» si può facilmente sentire un’eco
dell’«Emmanuele, Dio-con-noi», che aveva
aperto il Vangelo durante il racconto della nascita
di Gesù (1,23). La scena che conclude lo
scritto matteano è grandiosa e ha come fondale
il «monte che Gesù aveva indicato» ai suoi
discepoli, la cui fede è ancora vacillante («essi,
però, dubitavano»). Sappiamo quanto caro
all’evangelista sia il monte come simbolo
evocativo di quell’altra montagna sacra, culla
di Israele, il Sinai: non per nulla egli aveva
ambientato il primo dei cinque discorsi di Gesù
proprio su un monte di Galilea (5,1).
Ora i discepoli sono ancora in Galilea e davanti
a loro non c’è più soltanto quel maestro
che aveva vissuto, mangiato e parlato
con loro, ma il Risorto, e questo non è più un
semplice incontro ma una “cristofania”, cioè
un’apparizione pasquale, un’epifania di
“missione” (28,16-20). Infatti, le parole che
Cristo destina a questi undici apostoli titubanti
(«essi dubitavano», annota infatti
l’evangelista) sono un vero e proprio programma
missionario che si distenderà nei secoli
interpellando tutta la Chiesa. In questo
impegno non appare solo il sacramento
dell’iniziazione cristiana, quello dell’ingresso
nella fede pasquale, ossia il Battesimo, ma
anche l’insegnamento dei precetti di Cristo
che regolano l’intera esistenza del fedele.
Ormai si configura anche l’apertura universalistica
che valica le frontiere di Israele: «Fate
discepoli [si noti questa espressione che è ben
diversa da un semplice “ammaestrare”, come
talora si traduce] tutti i popoli». Si professa anche
la fede trinitaria: il Battesimo è amministrato
«nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo». Si proclama – evocando un passo
del profeta Daniele (7,14) – la signoria cosmica
di Cristo, il Pantokrator, come dirà la
tradizione greca successiva, cioè il sovrano di
tutto l’essere: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra». Ecco, infine, quella promessa
di essere sempre con noi ogni giorno,
sino alla meta finale dell’aiôn, un termine greco
che di per sé rimanda al tempo storico ma
anche a ciò che è in esso, vale a dire il mondo
e l’umanità. L’idea è, quindi, diversa rispetto
a una pura e semplice «fine del mondo». Si
tratta piuttosto della meta finale verso cui
converge la storia della salvezza; è il fine
più che la fine, è un approdo di pienezza.
Forse Matteo, le cui origini giudaiche affiorano
ininterrottamente nelle sue pagine, allude
alla ripartizione della storia in sette ère, suggerita
dalla tradizione apocalittica.
Ciascuna di esse comprendeva un arco di
mille anni, cifra ovviamente simbolica per
evocare un’immensa distesa di tempo. Si ricalcavano,
così, i sette giorni simbolici della
creazione, come è descritta nel capitolo 1 della
Genesi. Il Cristo risorto si erge, quindi, solenne
su tutta la sequenza della storia che
da Adamo giunge fino al momento estremo
quando «Cristo sarà tutto in tutti» (Colossesi
3,11). Egli si leva, possente e glorioso come
il Risorto dipinto da Piero della Francesca,
sulla sua Chiesa che ora è solo «un piccolo
gregge» di undici dubbiosi, ma che è destinata
ad allargarsi al mondo. E domina anche su
tutto il Vangelo di Matteo che ha celebrato
«Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo
» (1,1), ma anche «Emmanuele, che significa
Dio-con-noi» (1-23).
Pubblicato il 17 novembre 2011 - Commenti (1)
10
nov

Giona nella bocca della balena di Petrus Gilberti, inizio del XV secolo. Londra, British Library.
" Le acque mi
hanno sommerso
fino alla gola,
l'abisso mi ha
avvolto,
l'alga si è avvinta
al mio capo...
Ma tu fai risalire
dalla fossa
la mia vita,
Signore, mio Dio!"
(Giona 2,6-7)
«Salvami o Dio, l’acqua mi giunge alla
gola! Affondo in un abisso di
fango, non trovo un appiglio, sto
scivolando in acque profonde, travolto dalla
corrente!». Così urla il Salmista (69,2-3), anticipando
il grido di Giona che nel ventre del
grosso pesce che l’aveva inghiottito, simile a
una tomba, lanciava una supplica estrema a
Dio, modulata appunto sui testi salmici e incastonata
nel capitolo 2 di quel delizioso libretto.
Esso è, come si intuisce dal ricorso al
meraviglioso, una sorta di parabola che ha
per protagonista un profeta, Giona, il cui nome
in ebraico significa “colomba”, anche se
in realtà egli è più simile a un falco a causa
della sua chiusura mentale, ostile com’è
all’apertura verso i nemici.
La colomba, tra l’altro, era l’animale sacro alla
dea Ishtar, il cui santuario più acclamato era
situato proprio a Ninive, la capitale dell’Assiria,
alla quale il profeta era stato inviato in missione
dal Signore. Il segno cuneiforme che indica
questa città, tradizionale nemica di Israele, era
quello della casa e del pesce. E il pesce, come è
noto, è al centro del racconto, trasformato dalla
tradizione popolare in una balena, accolta anche
dal Pinocchio di Collodi. In realtà, il pesce
mostruoso – si pensi al Leviatan del libro di
Giobbe (40,25-41,26) – è simbolo del mare,
del caos acquatico che attenta alla vita, e
quindi è segno anche del giudizio divino.
Il profeta, renitente alla chiamata divina
che lo vorrebbe inviare a predicare proprio a
Ninive, si imbarca su una nave diretta all’antipodo,
cioè a Tarsis, forse l’attuale Gibilterra
o la Sardegna. Non manca neppure un pizzico
d’ironia quando si descrive Giona, ignaro
della tempesta che si è scatenata, mentre russa
pacificamente; al contrario, i marinai pagani
«pieni di timore verso il Signore, offrono
sacrifici e voti» (1,16) perché egli plachi il fortunale
marino. La storia dell’arte si è impossessata
di questa narrazione affascinante, rielaborandola
in mille forme, spesso sulla scia
dell’applicazione fatta da Gesù che, dalla permanenza
di tre giorni del profeta nel ventre
del pesce, aveva tratto «il segno di Giona»,
simbolo del sepolcro pasquale e della sua risurrezione
(Matteo 12,39-40).
Ma il libretto biblico vuole illustrare un’altra
tesi: è l’invito a spezzare il guscio dell’integralismo
e a condividere l’universalismo
della misericordia divina che abbraccia anche
il tradizionale nemico di Israele, l’Assiria
idolatra e persecutrice. Giona controvoglia è costretto
a predicare la conversione ai Niniviti e
con irritazione ne scopre l’esito positivo perché
quei pagani si pentono e cambiano vita, mentre
il profeta sperava in un’ostinazione che
avrebbe scatenato il giudizio divino. Con amarezza
giunge al punto di criticare un Dio troppo
«misericordioso e clemente, longanime e di
grande amore, che si lascia impietosire dopo
aver minacciato il giudizio» (4,2).
Alla fine, attraverso una parabola, quella
del ricino e del verme – che invitiamo a leggere
nel capitolo 4 del libro –, il Signore interpella
e ammonisce questo profeta ottuso e
chiuso nelle sue idee (e tutti coloro che sono
simili a lui) con un interrogativo che suggella
il racconto: «Giona, tu ti dai pena per questa
pianta di ricino [seccata e che non ti ripara
più dal caldo]... E io non dovrei aver pietà
di Ninive, la grande città, nella quale vi sono
più di centoventimila abitanti... e una grande
quantità di animali?» (4,10-11).
Pubblicato il 10 novembre 2011 - Commenti (2)
03
nov

Un fariseo, miniatura. Londra, British Library
" Perchè guardi
la pagliuzza
che è nell'occhio
del tuo fratello
e non ti accorgi
della trave che è
nel tuo occhio?"
(Luca 6,41)
«Un discepolo si era macchiato di
una grave colpa. Tutti gli altri reagirono
con durezza condannandolo.
Il maestro, invece, taceva e non reagiva.
Uno dei discepoli non seppe trattenersi e
sbottò: “Non si può far finta di niente dopo
quello che è accaduto! Dio ci ha dato gli occhi!”
Il maestro, allora, replicò: “Sì, è vero,
ma ci ha dato anche le palpebre!”». Siamo
partiti da lontano, con questo apologo indiano,
per commentare una delle frasi più celebri
del Vangelo, dedicata alla falsa correzione
fraterna.
Sappiamo, infatti, che lo stesso Gesù suggerisce
di «ammonire il fratello se commette
una colpa contro di te» (si legga il paragrafo
di Matteo 18,15-18). Ma è inesorabile contro
gli ipocriti che correggono il prossimo per
esaltare sé stessi e, anche in questo caso, è difficile
trovare una più incisiva lezione rispetto
a quella che ci è offerta dalla parabola del fariseo
e del pubblicano (Luca 18,9-14). In tutti
gli ambienti, anche in quelli ecclesiali, ci imbattiamo
in questi occhiuti e farisaici censori
del prossimo, ai quali non sfugge la benché
minima pagliuzza altrui, sdegnati forse
perché la Chiesa è troppo misericordiosa e, a
loro modo di vedere, troppo corriva.
Si ergono altezzosi, convinti di essere investiti
da Dio di una missione, consacrati al servizio
della verità e della giustizia. In realtà, essi
si crogiolano nel gusto sottilmente perverso
di sparlare degli altri e si guardano bene
dall’esaminare con lo stesso rigore la loro
coscienza, inebriati come sono del loro compito
di giudici. Ecco, allora, l’accusa netta di
Gesù: guarda piuttosto alla trave che ti acceca!
«Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio
di tuo fratello» (6,42). E poche righe prima,
in questo che gli studiosi hanno denominato
il “Discorso della pianura” (parallelo al
“Discorso della montagna” di Matteo), egli
aveva ammonito: «Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati!» (6,37).
Purtroppo, dobbiamo tutti confessare che
questo piacere perverso di spalancare gli occhi
sulle colpe del prossimo è una tentazione
insuperabile che ci lambisce spesso. Quel racconto
indiano che abbiamo citato in apertura
è accompagnato da un paio di versi di un celebre
e sterminato poema epico indiano, il
Mahabharata, che affermano: «L’uomo giusto
si addolora nel biasimare gli errori altrui,
il malvagio invece ne gode». Bisogna riconoscere
– come ribadiva l’umanista mantovano
Baldesar Castiglione (1478-1529) nel
suo trattato Il Cortegiano – che «tutti di natura
siamo pronti più a biasimare gli errori che a
laudar le cose bene fatte». Ritorniamo, comunque,
a quel discorso di Gesù proposto dal
Vangelo di Luca e riprendiamo un’altra frase
che sia da suggello a questa nostra riflessione
sull’ipocrisia: «Siate misericordiosi come il Padre
vostro è misericordioso» (6,36).
Pubblicato il 03 novembre 2011 - Commenti (3)
27
ott

Due fanciulli, Pablo Picasso (1952), Musée National Picasso, Parigi
" Ero con lui come
una giovane,
ero la sua delizia
ogni giorno,
giocavo davanti a
lui in ogni istante,
giocavo sul globo
terrestre..."
(Proverbi 8,30-31)
«Mentre la beata Umiliana giaceva
nel suo letto, ecco un bambino
di quattro anni, dal volto bellissimo.
Giocava con impegno proprio nella
sua cella davanti a lei che gli disse: “Carissimo
bambino, non sai fare altro che giocare?”.
E il bambino: “Che altro vuoi che faccia?”.
E la beata: “Voglio che tu mi dica qualcosa
di bello su Dio”. E il bimbo: “Credi che
sia bene che uno parli di sé stesso?”. E con
queste parole disparve». Questo episodio
della vita della beata Umiliana de’ Cerchi
(1219-1246), narrato dal suo biografo, fra Vito
da Cortona, ha certamente alla base un’allusione
alla frase evangelica sul diventare
piccoli come bambini per essere grandi nel
Regno dei cieli (Matteo 18,4).
Tuttavia, l’originalità sta nell’applicazione a
Dio stesso dell’immagine del bambino che gioca.
Ora, nel passo biblico che noi abbiamo
estratto da un inno grandioso in cui la Sapienza
divina si autopresenta, si ha una sorprendente
metafora per definirla: è quella da
noi tradotta con «giovane». In realtà, in ebraico
abbiamo un termine che non ricorre altrove
nella Bibbia, ’amôn (si trova, però, due volte
nella variante hamôn) e che potrebbe designare
anche un “architetto, artefice”, ma è possibile
pure la resa “ragazzo, giovane”.
Sia nell’uno sia nell’altro caso la Sapienza
del Creatore – che in questo inno è personificata
sotto i tratti di una figura femminile – sarebbe
raffigurata con simboli che evocano arte,
festa, bellezza. A spingerci verso l’immagine
della ragazza è proprio il verbo successivo
che per due volte parla di “gioco”. Nelle distese
immense dei cieli, negli spazi mirabili
della natura Dio sembra del tutto immerso
in un atto creativo libero e appassionato,
un po’ come accade al bambino quando sta
giocando. Tutte le sue energie intellettuali e
fisiche sono assorbite in quel piacere intimo
e totale. È ciò che si ripete per l’artista quando
è coinvolto nella sua attività creatrice: nulla
lo distrae e il suo spirito e il suo corpo sono
totalmente consacrati all’opera che sta uscendo
dalle sue mani.
Ebbene, non di rado in teologia si è ricorsi
proprio al simbolo del gioco e della creazione
artistica per parlare “analogicamente” di
Dio. Chi conosce qualcosa di questa scienza
sacra avrà sentito parlare, ad esempio,
dell’“analogia estetica” sviluppata dal teologo
svizzero Hans Urs von Balthasar, oppure
di quella “ludica” (cioè legata all’immagine
del gioco) suggerita dall’americano Harvey
Cox. Il gioco puro, senza l’inquinamento
dell’interesse o della violenza come avviene
oggi in certi sport, il gioco innocente e libero
del bambino può essere un’analogia, cioè un
modo umano adatto a descrivere la divinità,
la felicità di Dio e in Dio.
L’abbandono di tutto l’essere che l’artista,
come si diceva, sperimenta nell’istante
creativo si trasforma in un segno visibile
dell’infinita perfezione della mente e
dell’azione del Creatore. C’è, a questo proposito,
un testo molto suggestivo di Lutero
che, ammiccando idealmente al passo del libro
dei Proverbi da noi proposto, così dipinge
la meta ultima della storia e dell’essere:
«Allora l’uomo giocherà con il cielo e con la
terra, giocherà con il sole e con tutte le creature.
Tutte le creature proveranno anche un
piacere immenso, un amore immenso, una
gioia lirica, e rideranno con te, o Signore, e
tu a tua volta riderai con loro».
Pubblicato il 27 ottobre 2011 - Commenti (1)
20
ott

Innamorati sotto un albero in fiore (1859) di John Callcott Horsley, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia
" Mi ricordo di te,
dell'affetto della
tua giovinezza,
dell'amore
al tempo del tuo
fidanzamento,
quando mi seguivi
nel deserto,
in una terra
non seminata."
(Geremia 2,2)
«Enlil, le tue molte perfezioni fanno
restare attoniti, la loro natura segreta
è come una matassa arruffata
che nessuno sa dipanare, è un arruffio di
fili di cui non si trova il bandolo». È, questa,
una strofa di un antichissimo inno sumerico
dedicato al dio Enlil, il capo del pantheon
di quella civiltà. Essa ben esprime
una concezione della divinità per certi versi
affine alla visione greca del Fato, un gorgo
oscuro e misterioso che impera sugli stessi
dèi, piegandoli a una logica indecifrabile.
Anche uno dei “bellissimi nomi” di Allah è
“l’inaccessibile” e – sia pure con una prospettiva
teologica ben più alta – l’islam considera
la divinità come invalicabile a ogni
conoscenza intima, che non sia quella negativa
(«Dio non è come...»).
Su tutt’altra traiettoria si muove, invece, la
Bibbia che non solo presenta il Signore come
una persona che può dire: «Io sono», ma anche
ne descrive i sentimenti, le passioni,
l’amore. È il caso di questo stupendo soliloquio
di Dio che ci ha lasciato Geremia: in esso
brillano sia la tenerezza di una relazione tra
due fidanzati, sia l’«affetto» profondo che li
unisce. Il termine ebraico usato, hesed, rimanda
infatti alla fedeltà amorosa che intercorre
tra due innamorati, vincolati tra loro non da
un obbligo legale, bensì da un patto d’amore.
Nello stesso libro profetico si legge questa appassionata
professione d’amore di Dio: «Ti ho
amato di amore eterno, per questo ti conservo
il mio affetto» (31,3).
C’è, però, una nota stonata da registrare. Il
frammento geremiano da noi proposto è incastonato
in un brano che in ebraico è detto rîb,
ossia un “dibattimento processuale”, una “lite
giudiziaria”. Sì, perché in realtà questa
sposa, Israele, così amata, si è rivelata una
donna infedele. Anzi, il profeta usa un’immagine
durissima, “bestiale”: «Come una giovane
cammella leggera e vagabonda, come asina
selvatica, abituata al deserto, ansima
nell’ardore della sua voglia: chi può frenare
la sua brama?» (2,23-24). La metafora è esplicitata
nella sua dimensione religiosa, quando
questa sposa dichiara la sua scelta: «Io amo
gli stranieri, voglio andare con loro!» (2,25).
Gli amanti «stranieri» sono gli idoli. Come è
evidente, la simbologia d’amore viene usata
in tutte le sue iridescenze per descrivere l’esaltante
e travagliato rapporto nuziale tra il Signore
e il suo popolo.
Israele è «una donna infedele a chi la ama»
(3,20), «è sfrontata come una prostituta che
non arrossisce» (3,3), sta in attesa dei suoi
clienti ai crocicchi delle strade «come fa l’arabo
nel deserto» (3,2). Eppure, come dice il nostro
frammento, Dio è pieno di nostalgia
per il passato d’amore vissuto insieme nel
deserto del Sinai. In verità, anche là Israele
aveva tradito, ma il Signore sembra quasi scordare
ogni infedeltà e alonare di luce quella fase
antica, nella speranza di un futuro diverso,
anche perché «egli non mantiene rancore per
sempre né conserva in eterno la sua ira» (3,5).
Ecco, allora, il ripetersi nel capitolo 3 – che fa
parte sempre dello rîb o contesa tra Dio e
Israele – per sette volte del verbo shûb, il “ritornare-
convertirsi” (3,1.7.10.12.14.19.22). È il
desiderio segreto anche del popolo peccatore,
ma è soprattutto l’attesa insonne di Dio: «Ritorna,
Israele ribelle, non ti mostrerò la faccia
sdegnata perché io sono affettuoso e non conserverò
per sempre l’ira» (3,12).
Pubblicato il 20 ottobre 2011 - Commenti (1)
13
ott

San Giovanni evangelista di Antonie Van Dyck (1599-1641). Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.
“ Questo è l'amore:
camminare
secondo i suoi
comandamenti.
E il comandamento
che avete appreso
fin dal principio
è questo:
Camminate
nell'amore!"
(2Giovanni 6)
«Dovessi scrivere io un trattato di morale,
avrebbe cento pagine, novantanove
delle quali assolutamente
bianche. Sull’ultima scriverei: conosco un solo
dovere, quello d’amare. A tutto il resto dico no».
Così annotava, nel settembre 1937 nei suoi Taccuini,
lo scrittore ateo francese Albert Camus.
Egli che era, però, un uomo in ricerca coglieva il
cuore della morale cristiana, quell’unico, primo
e fondamentale comandamento che Cristo
ci ha lasciato e che soprattutto l’evangelista
Giovanni ha illustrato, sia attraverso le
parole di Gesù nell’ultima sera della sua vita terrena,
sia con le proprie parole nelle tre Lettere
che recano il suo nome.
Noi abbiamo scelto un frammento della Seconda
Lettera, che è quasi un biglietto di una
manciata di versetti (tredici), così come la Terza
Lettera indirizzata a un non meglio noto Gaio,
un discepolo dell’apostolo, elogiato per la sua
generosa ospitalità verso i missionari cristiani
itineranti. In entrambi i testi l’autore si presenta
come «il Presbitero», l’Anziano, titolo riservato
ai capi delle comunità cristiane e che la tradizione
ha voluto identificare con Giovanni.
Il destinatario, nel nostro caso, è la Chiesa locale,
certamente una comunità dell’Asia Minore,
suggestivamente chiamata «la Signora eletta
da Dio», circondata dai suoi «figli» che sono i fedeli.
Tuttavia, all’orizzonte si intravedono ombre
cupe: «Molti seduttori si sono introdotti nel
mondo: essi non confessano che Gesù Cristo è
venuto nella carne. Costoro sono il seduttore e
l’anticristo!» (versetto 7). Si fa strada quella che
verrà denominata eresia “gnostica” che, volendo
esaltare la purezza spirituale della
“conoscenza” (in greco gnosis) divina, aveva
cancellato la pesantezza della “carne” di
Cristo, giungendo alla negazione dell’Incarnazione,
il mistero cristiano centrale.
San Giovanni, nel prologo innico del suo
Vangelo, era stato netto: il Logos divino, il “Verbo”,
si è fatto sarx, “carne”, in Gesù Cristo
(1,14), inserendosi a pieno titolo nell’umanità.
Ora questa dottrina fondamentale è messa in
crisi. Ma, accanto a questo smarrimento teologico
e ideale, ce n’è un altro morale e pratico: si
sta raffreddando il fuoco dell’amore. Ecco, allora,
l’appello caloroso del passo da noi citato
che evoca «il comandamento nuovo», anzi, «il
mio comandamento», come lo chiamava Gesù,
«che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato
voi» (Giovanni 13,34; 15,12).
Per questo si parla di «un comandamento appreso
fin dal principio», perché ha le sue radici
in Cristo e nel suo lascito spirituale, vincolato
all’esempio stesso della sua donazione nella
morte. Molto intensa è l’immagine che ora «il
Presbitero» presenta ai suoi interlocutori: «camminare
nell’amore». La via è il simbolo della
vita e il cristiano deve avere come insegna
permanente dei suoi giorni e delle sue ore
proprio quella parola, agápe, “amore”, la parola
che brilla negli scritti giovannei e che anche
in questo biglietto affettuoso, sebbene striato
dall’ansia per la degenerazione della fede di
quei cristiani, risplende nell’attesa «di venire
da voi e di poter parlare a viva voce, perché la
nostra gioia sia piena» (versetto 12).
Pubblicato il 13 ottobre 2011 - Commenti (2)
06
ott

Pianto di ragazza (1964), opera di Roy Lichtenstein.
“ Il Signore
Dio eliminerà
la morte
per sempre,
asciugherà
le lacrime
su ogni volto,
farà scomparire
da tutta la terra
l'ignominia
del suo popolo."
(Isaia 25,8)
È noto che il “rotolo” di Isaia è, per così dire,
scritto con più inchiostri e a più mani:
diversi, infatti, sono gli autori profetici
che vi prendono parte e differenti sono i
temi, le tonalità e le coordinate storiche. Ora
noi abbiamo ritagliato un versetto da una
sorta di fascicolo di oracoli, intrecciati a suppliche
e inni, che occupa i capitoli 24-27 del
libro del grande Isaia e che gli studiosi hanno
denominato “l’Apocalisse di Isaia”. Le immagini,
lo stile, i soggetti, infatti, hanno le
caratteristiche di quella particolare letteratura
chiamata “apocalittica” (dal greco apokálypsis,
“rivelazione”), che ha il suo avvio
con il profeta Ezechiele, il suo trionfo con Daniele
e con Zaccaria e che approda nel Nuovo
Testamento con l’Apocalisse di Giovanni.
È significativo che proprio quest’ultimo libro
citi esplicitamente il nostro passo isaiano
nel suo glorioso ritratto della Gerusalemme
nuova e perfetta e lo faccia ben due
volte: «L’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il pastore [degli eletti] e li guiderà alle
fonti dell’acqua della vita. E Dio asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi... E asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più
la morte né lutto né lamento né affanno perché
le cose di prima sono passate» (Apocalisse
7,17; 21,4). Ritorniamo ora al testo originario,
quello presente nel libro di Isaia. Esso fa
parte di un canto più ampio (25,6-10a) che
ha al centro un simbolo divenuto celebre nella
tradizione giudaica e cristiana.
Lasciamo la parola al profeta: «Il Signore
degli eserciti preparerà per tutti i popoli su
questo monte un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti,
di vini raffinati» (25,6). Dio, quindi,
entra in scena come un re che imbandisce
un pranzo ufficiale dal menù prelibato. Sappiamo
che la mensa è un segno di amicizia e
di intimità in tutte le civiltà. Il Signore, perciò,
vuole unirsi idealmente all’intera umanità,
ma lo fa nella sua sede che è il monte
Sion a Gerusalemme.
Per rendere agevole questo afflusso universale
egli deve togliere il velo di nubi che separa
quella vetta, deve eliminare la coltre di tenebra
che come un sudario di morte si stende
sulla terra, così che possa brillare la luce e
tutti possano camminare al suo fulgore.
Quando tutti si sono accomodati ai loro posti
attorno alla mensa, il Signore passa in mezzo
a loro per tergere i segni della sofferenza e
della fatica che contaminano i volti. È un atto
di ospitalità suprema che sfocia in una promessa
assolutamente unica che solo Dio può
fare: «Eliminerà la morte per sempre!».
A questo punto sboccia dalle labbra di tutti
un canto festoso: «Ecco il nostro Dio! In lui abbiamo
sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore
in cui abbiamo sperato; rallegriamoci,
esultiamo per la sua salvezza!» (25,9). È facile
comprendere come questa scena luminosa
e gioiosa sia divenuta il quadro ideale per
raffigurare l’ingresso glorioso del Messia
nella storia. Ma sia anche la rappresentazione
della meta ultima della vicenda umana così
come l’attende la fede biblica, un approdo
nella vita piena e perfetta. È ciò che aveva già
annunziato un altro profeta, Osea, e le sue parole
erano state riprese da san Paolo: «Li strapperò
dalla mano degli inferi, li riscatterò dalla
morte? Dov’è, o morte, la tua peste? Dov’è,
o inferi, il vostro sterminio?» (13,14). Ma il
profeta era ancora scettico; l’Apostolo, invece,
non avrà esitazioni perché commenterà quel
passo così: «Questo corpo corruttibile si rivestirà
di incorruttibilità e questo corpo mortale
di immortalità» (1Corinzi 15,54-57).
Pubblicato il 06 ottobre 2011 - Commenti (2)
29
set

Gesù precipita Satana di Mattia Preti (1613-1699). Napoli, Museo di Capodimonte.
“ La superbia
del tuo cuore
ti ha sedotto...
Anche se,
come aquila,
riesci a porre in
alto il tuo nido,
anche se lo
collocassi tra
le stelle,
di lassù io ti farò
precipitare."
(Abdia 3-4)
«Dovunque egli arrivi, il superbo si
mette a sedere e tira fuori dalla
valigia la sua superiorità». Con
ironia lo scrittore ebreo bulgaro-tedesco Elias
Canetti, Nobel 1981, nel suo libro Un regno di
matite, dipingeva questo che è il primo e fondamentale
vizio capitale che già alligna nel
giardino dell’Eden: «Sarete come Dio» è, infatti,
la promessa che il tentatore fa all’orgoglio
di Adamo. Questa attrazione perversa che
fa dell’Io un dio idolatrico è raffigurata in
modo folgorante anche dall’autore del più
breve di tutti i libri profetici, Abdia, il cui
nome è un emblema, “Servo del Signore”. Di
lui non sappiamo nulla e l’unica pagina di 21
versetti di cui si compone la sua opera echeggia
eventi di difficile decifrazione e collocazione
cronologica.
Si pensi, poi, che quasi la metà di questa pagina
(versetti 2-9) si ritrova anche nel più lungo libro
dell’Antico Testamento, quello del profeta
Geremia (49,7-22), sia pure con variazioni. Ma
lasciamo agli esegeti di esercitarsi sull’enigma
Abdia e puntiamo sul frammento che abbiamo
scelto, ritagliandolo all’interno del suo canto
polemico – dominante nel suo scritto – contro
Edom, uno dei tradizionali nemici di Israele,
un popolo discendente da Esaù, il fratello maggiore
di Giacobbe-Israele, da quest’ultimo ingannato
e quindi divenuto vittima del suo odio
(Genesi 25,19-34 e 27,1-46).
Un odio che era dilagato anche nei loro discendenti
e che è suggellato qui da Abdia con
la sua accusa nei confronti di Edom, «ingannato
dalla superbia del suo cuore». Questa
nazione bellicosa del deserto che, come dice
Abdia, «abita nelle caverne della roccia»,
un’allusione alla sua capitale, Ha-Sela’ (2Re
14,7), forse Petra in Giordania, «dice in cuor
suo: Chi potrà scagliarmi a terra?». Ecco, allora,
il severo giudizio divino che umilia i superbi.
La scena è molto vivida: l’aquila riesce
a collocare il suo nido in alture irraggiungibili
da piede umano e col suo volo maestoso
sembra mirare alle stelle.
È questo il simbolo più efficace per illustrare
l’arroganza del superbo che vorrebbe sfidare
Dio, ascendendo verso il cielo, in un atto
blasfemo e dissacratorio. È quello che Isaia
rappresenta in una delle sue pagine più potenti
nella quale il profeta mette in scena il grande
“imperatore” di allora, il re di Babilonia, la
superpotenza orientale. Il suo è un sogno – che
potremmo chiamare “apoteosi”, usando una
parola di origine greca che designa la “divinizzazione”
– un sogno tratteggiato appunto come
un’ascensione celeste: «Salirò in cielo, sulle
stelle di Dio innalzerò il mio trono, risiederò
sul monte dell’assemblea divina... Salirò sulle
regioni che sovrastano le nubi, mi farò uguale
all’Altissimo» (Isaia 14,13-14).
Ma subito dopo, proprio come nella breve e
icastica finale del passo di Abdia, anche Isaia introduce
una svolta radicale: «E invece, sei stato
precipitato negli inferi, scaraventato nelle profondità
degli abissi» (14-15). La meta del folle
volo orgoglioso del re di Babel e di quello di
Edom non è lo zenit divino ma il nadir infernale:
l’ascensione si trasforma in una discesa
precipite e catastrofica. È, questa, la lezione
che il testo del misterioso profeta che conosciamo
come Abdia ci lascia nel frammento della
sua brevissima profezia, siglata in finale da
una frase netta e definitiva: «Il regno sarà del Signore
» (versetto 21). Il pensiero corre, allora, alle
parole di Cristo: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come folgore» (Luca 10,18).
Pubblicato il 29 settembre 2011 - Commenti (2)
22
set

Coppia di amanti, miniatura persiana, Philadelphia, Free Library.
“Il mio amato
è mio e io
sono sua...
Io sono
del mio amato
e il mio amato
è mio."
(Cantico 2,16; 6,3)
Basta sapere che in ebraico i suoni ô e î
indicano rispettivamente la terza persona
(“lui, suo”) e la prima (“io, mio”),
e anche chi ignora questa lingua sentirà l’armonia
simbolica dei due versetti che abbiamo
desunto da quel gioiello poetico e spirituale
che è il Cantico dei cantici. In essi, infatti,
quei due suoni ricorrono come un dolce filo
musicale che canta la piena e assoluta reciprocità
della donazione d’amore. Provate,
perciò, a leggere e rileggere queste frasi in
ebraico e sentirete il dominio di quei due suoni,
l’“io” e “lui” che si abbracciano: dodì li
wa’anì lo…’anì ledodì wedodì li.
Questa «formula della mutua appartenenza
», come l’ha definita un commentatore
francese, André Feuillet, è la riedizione ideale
del primo ed eterno inno d’amore
dell’Adamo universale quando incontra la
sua Eva: «Carne della mia carne, osso delle
mie ossa» (Genesi 2,23). È una professione
d’amore, affidata a quattro sole parole ripetute
che diventano un programma di vita coniugale.
Il matrimonio autentico si fonda su
una reciproca donazione d’amore di anime e
di corpi, per cui si è «una carne sola» ossia,
nel linguaggio biblico, un’unica esistenza.
Protagonisti di questo poemetto biblico sono
un Lui e una Lei senza nome, perché incarnano
gli innamorati di ogni terra e di ogni
epoca: le allusioni a Salomone e a una Sulammita
sono solo simboliche, soprattutto perché
questi termini evocano la parola ebraica shalôm,
“pace”. Questo realismo costituisce, però,
la base per intessere una rete di rimandi
ulteriori. L’amore della coppia umana, quando
ha in sé questa totalità di dono per cui rivela
una comunione perfetta, si trasfigura
in un segno divino. Per questo non pochi esegeti
hanno fatto notare che la duplice formula
del Cantico sopra citata ne echeggia un’altra.
Essa suona sostanzialmente così: «Il Signore
è il tuo Dio e tu sei il suo popolo».
È la cosiddetta “formula dell’alleanza” tra il
Signore e Israele. Inizialmente questo legame
era stato modulato secondo i canoni delle alleanze
diplomatico-politiche tra un re e i suoi
principi vassalli. Al Sinai si era steso quasi un
protocollo siglato con un rito di sangue (Esodo
24,1-11): era un patto reciproco di fedeltà a
diritti e doveri specifici. Con Osea e la sua
drammatica vicenda matrimoniale di marito
abbandonato e tradito si era introdotta una
svolta radicale: quell’alleanza non era più tra
due potenze ma tra due amori.
Il simbolo nuziale era stato adottato per
descrivere il vincolo tra Dio e il suo popolo.
La formula del Cantico può, così, essere sovrimpressa
a quella dell’alleanza col Signore,
così da farle acquistare quel connotato
d’amore e di fedeltà che i profeti, da Osea in
avanti, avevano esaltato. In questa luce, la
professione di reciproca donazione e comunione
tra i due protagonisti del Cantico viene
riletta in chiave religiosa e trasforma il
poemetto biblico in un testo mistico, destinato
a essere quasi il canto di nozze tra Dio e
il suo popolo. In realtà, il Cantico dei cantici
rimane ancorato alla storia di un amore umano,
ma il suo valore intimo può espandersi fino
ai cieli e riflettere la luce del Dio che è
amore (1Giovanni 4,8.16).
Pubblicato il 22 settembre 2011 - Commenti (2)
|
|