05
nov

Creature infernali divorano i dannati, miniatura di scuola francese tratta dall’Apocalisse di Cambrai, secolo XIII, Ms. 422. Cambrai, Francia, Biblioteca Municipale.
"Essere gettati nella Geenna
dove il loro
verme non muore
e il fuoco non si
estingue.
Ognuno sarà salato col fuoco".
(Marco 9,47-49)
Questa frase di Gesù è, per il lettore
moderno, un condensato di oscurità
che cercheremo di dissolvere
assumendone le singole componenti. Partiamo
dalla più facile, la Geenna.
Cristo
sta denunciando il peccato dello scandalo
che fa inciampare «questi piccoli che
credono in me» (Marco 9,42), cioè chi è
fragile nella fede e può essere facilmente
messo in crisi.
Ebbene, lo scandalizzatore
corre il rischio di essere gettato nella
Geenna che era popolarmente divenuta
un sinonimo di inferno. Ma che
cos’era in sé, prima di diventare un simbolo
della pena dei malvagi? Era una valle
il cui nome topografico completo in
ebraico era Ghe’-ben-Hinnon, ossia “valle
del figlio di Hinnon”, deformato nel greco
Gheenna, donde il nostro Geenna.
Ma come s’era acquistata questa triste
fama? Secondo quanto riferiscono alcuni
testi biblici (Geremia 19; 2Re 23,10), la valle
era stata trasformata nella discarica di
Gerusalemme, dato che si distendeva nella
periferia ovest e sud dell’antica città.
Là i rifiuti venivano inceneriti e là si compivano
anche riti infami come i sacrifici
di bambini, passati attraverso il fuoco, in
onore del dio fenicio Molok, sacrifici proibiti
dalla legge biblica (Levitico 18,21), eppure
praticati anche da due re di Giuda,
Acaz e Manasse. Facile era, quindi, considerare
quel luogo impuro (sia materialmente
sia religiosamente) come la sede
della condanna degli empi, l’inferno dalle
fiamme inestinguibili.
Si spiega, così, il fuoco che viene evocato
nel prosieguo della frase attraverso
una citazione del profeta Isaia, che
nell’ultimo versetto del suo libro (66,24)
descrive il giudizio divino su «coloro che
si sono ribellati a me: il loro verme non
morirà e il loro fuoco non si estinguerà
». Se l’immagine ignea è chiara per il
nesso con la Geenna, che cos’è invece il
“verme”? Il riferimento è a quelle larve
che si sviluppano negli alimenti o nei vegetali,
ma anche nei corpi malati creando
infezioni, come confessa Giobbe: «Purulenta
di vermi e di croste squamose è
la mia carne» (7,5). Oppure come accadde
al re Erode Agrippa, persecutore dei
primi cristiani, che similmente al nonno
Erode il Grande, morì «divorato dai
vermi» (Atti 12,23).
Il simbolo è, dunque, evidente: la punizione
del malvagio è incessante, analoga
a un fuoco inestinguibile e a un verme
che non lascia scampo alla carne.
Infine c’è il sale che viene anch’esso collegato
al fuoco. Di per sé questa realtà, tipica
in cucina, ha due aspetti.
È segno di solidarietà,
forse anche per la sua funzione
concreta di dar sapore ai cibi («Voi siete il
sale della terra», dirà Gesù in Matteo 5,13)
e vigore al corpo (il neonato veniva frizionato
con sale, secondo Ezechiele 16,4):
non per nulla nella Bibbia si parla di
«un’alleanza di sale, perenne, davanti al
Signore» (Numeri 18,19).
Nella nostra lingua
lo strumento economico della sopravvivenza,
lo stipendio, viene chiamato “salario”
e il libro di Esdra definisce i funzionari
persiani come «coloro che mangiano
il sale della reggia» (4,14).
C’era, però, un altro aspetto, questa
volta negativo. Evocando la fine di Sodoma
e Gomorra sotto una pioggia di sale,
zolfo e fuoco (Genesi 19), si rappresentava
il giudizio divino come una sorta di
crogiuolo nel quale si castigavano
atrocemente i peccatori salandoli e
bruciandoli. Il sale che conserva i cibi
presenterebbe l’aspetto permanente di
quella punizione. Qualche codice che ci
ha trasmesso i Vangeli e la Vulgata, cioè
la versione latina della Bibbia di san Girolamo,
ha applicato invece l’immagine alle
prove dei giusti trasformando la frase
con questa aggiunta, che rimanda al rito
di salatura delle vittime sacrificali (Levitico
2,13): «Ognuno sarà salato col fuoco e
ogni vittima sarà salata con sale».
Pubblicato il 05 novembre 2012 - Commenti (2)
30
ott

Raffaello Sanzio, Trasfigurazione, 1518-1520, particolare. Città del Vaticano, Musei, Pinacoteca.
"Mio figlio ha uno spirito muto:
lo afferra, lo getta per terra
ed gli schiuma, digrigna i denti
e si irrigidisce".
(Marco 9,18)
Siamo ai piedi del monte della Trasfigurazione.
Gesù ha appena svelato
a tre apostoli, Pietro, Giacomo
e Giovanni, il mistero della sua persona
di Figlio di Dio celato sotto le spoglie
della sua umanità.
Nella pianura
sottostante s’imbatte in un caso che è
classificato come possessione diabolica,
secondo la comune concezione di allora
(ma non solo) di interpretare uno stato
patologico psicofisico riportandolo a
una radice demoniaca (Marco 9,14-29).
Lo stesso era accaduto anche nel caso,
già da noi affrontato, del malato mentale
“indemoniato” di Gerasa (5,1-20).
Che si tratti, invece, di epilessia appare
dalla stessa descrizione fatta dal
padre di questo giovane e che noi abbiamo
messo in evidenza nella citazione
del passo dell’evangelista Marco.
Inoltre, condotto davanti a Gesù, il ragazzo
è preso dalle «convulsioni, cade a
terra e si rotola spumando» (9,20) e il
padre ricorda che «fin dall’infanzia» gli
accadeva questo, al punto di «buttarsi
anche nel fuoco e nell’acqua», in atteggiamento
autolesionistico (9,21-22). Siamo
in presenza della tipica sintomatologia
dell’epilessia, rubricata popolarmente
sotto uno «spirito muto» demoniaco,
secondo la cultura del tempo.
In realtà, Gesù si è trovato di fronte al
satanico in senso stretto, come abbiamo
visto in una precedente analisi di un testo
marciano (1,21-26) all’interno della sinagoga
di Cafarnao. Altre volte, invece,
ha davanti a sé semplicemente il limite
dell’uomo, il male fisico e psichico. Si tratta
della nostra imperfezione e creaturalità
che ci fanno soffrire; è la nostra incompiutezza
umana che comporta caducità,
dolore e morte. Questa dimensione negativa
nell’antica mentalità era sempre
da ricondurre o a una colpa del soggetto
o a un intervento demoniaco.
La figura di Cristo, come si erge liberatrice
nei confronti delle possessioni diaboliche,
ingaggiando una lotta con lo
“spirito impuro” che devasta la creatura,
spingendola al male, così si leva contro
il male fisico e psichico, orizzonte
nel quale Dio sembra assente, ma dove
in verità può rivelare la sua presenza salvifica
che è somatica e spirituale al tempo
stesso. È interessante notare i verbi
usati nel finale del racconto. «Il fanciullo
diventò come morto, sicché molti dicevano:
È morto (apéthanen)! Ma Gesù
lo prese per mano, lo risvegliò (égheiren)
ed egli sorse in piedi (anéste)».
Ebbene, questi sono i tre verbi greci
usati nel Nuovo Testamento per definire
la morte e la risurrezione di Cristo, sorgente
di ogni liberazione dalla morte e
dal male. La salvezza che egli offre è,
quindi, piena: tocca la nostra creaturalità
fragile, ma anche il peccato e le seduzioni
che Satana e il male esercitano
sulla nostra libertà facendola inclinare
verso il vizio.
Certo, dobbiamo evitare,
da un lato, gli eccessi di “satanismo”
facendone quasi il centro della fede cristiana
che è, invece, occupato da Dio e da
Cristo. Dobbiamo stroncare la morbosità
“satanica” in ambito magico, riconoscendo
il primato di Dio e affidando in molti
casi anche ad altre discipline il loro compito
terapeutico, come la medicina e la
psicologia.
Ma non dobbiamo dimenticare
il monito di san Pietro: «Il vostro nemico,
il diavolo, simile a un leone ruggente,
s’aggira cercando chi divorare; resistetegli
saldi nella fede!» (1Pietro 5,8-9).
Pubblicato il 30 ottobre 2012 - Commenti (2)
18
ott

Trasfigurazione di Giovanni Battista Paggi (1554-1627). Firenze, San Marco.
"In verità io vi dico:
vi sono alcuni,
qui presenti,
che non morranno
prima di aver
visto giungere
il regno di Dio
nella sua potenza".
(Marco 9,1)
Frase a prima vista sconcertante,
questa, per quel rimando alla generazione
contemporanea di Gesù
che sarebbe spettatrice o della venuta
del regno di Dio (così nel passo qui citato
di Marco 9,1 e in Luca 9,27) o del «Figlio
dell’uomo che viene nel suo regno
», secondo la variante di Matteo
(16,28). Fermo restando che gli evangelisti
spesso riprendono le parole di Gesù
Cristo incarnandole nel contesto ecclesiale
in cui essi sono immersi, sorge
spontanea una domanda: cosa s’attendevano
di vedere quei primi cristiani
durante la loro vita terrena?
Le risposte date dagli esegeti sono diverse:
Gesù allude alla successiva epifania
gloriosa della sua trasfigurazione
oppure alla sua risurrezione, o ancora
alla distruzione di Gerusalemme del 70,
tutti segni espliciti e “visibili” della venuta
del regno di Dio nella storia. In
realtà, il centro della questione è in
quel «regno di Dio», uno dei temi portanti
della predicazione di Gesù, da lui
desunto dall’Antico Testamento e sviluppato
in modo originale. Si tratta di
una metafora per descrivere il progetto
trascendente ed eterno di Dio nei confronti
della storia umana. Cristo afferma
di essere venuto a rivelarlo e a metterlo
in opera.
Ora, poiché il regno è una realtà eterna,
voluta da Dio per trasformare l’essere,
è in sé “puntuale”, è già “ora” e sempre;
tuttavia, esso si insedia visibilmente
nella storia che è fatta di uno sviluppo,
di un “prima” e di un “poi” e, quindi,
avrà diverse fasi di attuazione.
L’azione di Cristo rende presente il regno
di Dio già da adesso: «Se io scaccio i
demoni per virtù dello Spirito di Dio, è
certo giunto tra voi il regno di Dio»
(Matteo 12,28); «il regno di Dio non viene
in modo da attrarre l’attenzione e
nessuno può dire: “Eccolo qui, o eccolo
là!”. Perché il regno di Dio è in mezzo a
voi» (Luca 17,21).
Eppure, il regno dei cieli è una realtà
che dovrà innervare il futuro e, quindi,
è ancora da attendere. Allora, la frase citata
di Gesù invita a riconoscere la presenza
del regno nella persona e nell’opera
di Cristo: la salvezza che egli compie
con le sue guarigioni e i suoi esorcismi
mostra che quel progetto salvifico è già
in azione e allarga i suoi confini sottraendo
spazio al Male. I contemporanei sono
invitati a scoprirne la presenza viva ed efficace
proprio nella figura di Gesù.
Tuttavia, non si deve immaginare
che Gesù pensi già a una sorta di fine
del mondo e alla sua venuta ultima e
definitiva già entro la sua generazione,
dopo la sua morte e risurrezione.
Ci sono, infatti, varie sue affermazioni
– soprattutto all’interno del cosiddetto
“discorso escatologico” (Matteo 24-25;
Marco 13; Luca 21) – ove a questo presente
s’intreccia il futuro della pienezza
non ancora compiuta nella sequenza
del tempo a cui noi tutti apparteniamo,
sia pure in epoche differenti.
In sintesi, il regno di Dio, essendo
eterno, abbraccia e supera il tempo e,
quindi, si svela in azione in modo forte
con Cristo, la sua opera, la sua parola e
la sua Pasqua durante quella generazione,
ma anche nelle successive. Esso, però,
si proietta nel futuro fino alla “pienezza
dei tempi”, quando il regno avrà
raggiunto la sua attuazione perfetta e
conclusiva.
Pubblicato il 18 ottobre 2012 - Commenti (2)
15
ott

Gesù guarisce un cieco, affresco, scuola cassinese. Sant'Angelo in Formis, Capua.
"Quegli, alzando gli occhi, diceva:
«Vedo la gente, perché vedo
come degli alberi che camminano»".
(Marco 8,24)
Ambientato a Betsaida (in aramaico “casa
dei pescatori”), la patria degli apostoli
Pietro, Andrea e Filippo, villaggio situato
sul lago di Tiberiade, questo miracolo
piuttosto sorprendente mette in scena un Gesù
che non riesce a guarire un cieco se non attraverso
due interventi successivi.
È solo Marco a
narrarci questo episodio dal carattere storico
e simbolico al tempo stesso. Storico, perché
non si sarebbe mai inventato un atto miracoloso
che mostra un Gesù incapace di guarire
di primo acchito, ma costretto a ripetere l’operazione
sul malato. Simbolico, per la tipologia
del paziente e il contesto che assegna all’evento
un probabile significato ulteriore.
Iniziamo con la vicenda concreta. Secondo
la tradizionale convinzione per la quale si assegnava
alla saliva un potere terapeutico, Gesù
spalma la sua saliva sugli occhi di un cieco, come
farà a Gerusalemme con un caso congenito
analogo (Giovanni 9,6).
Impone poi le mani sul
malato e attende l’esito che è, però, piuttosto
imprevisto: il cieco comincia, sì, a vedere ma
confessa di intuire le figure umane in maniera
confusa, come se fossero alberi in movimento.
Cristo, allora, ripete l’imposizione delle mani
«ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano
vedeva distintamente ogni cosa» (Marco
8,25).
Segue il monito, frequente nel Vangelo
di Marco, di evitare ogni pubblicità al gesto:
«Non entrare nemmeno nel villaggio», impone
Gesù all’ex cieco (8,26).
Espressione dell’umanità di Cristo che si
lega alle tradizioni mediche popolari e che
rivela persino una difficoltà operativa, questo
racconto ha, però, su di sé un velo simbolico
suggestivo. Innanzitutto per la sindrome
in questione, la cecità.
Certo, il fenomeno era
in sé fisico, derivante anche dalle infezioni
oftalmiche purulente, provocate o aggravate
dal sole incandescente, dal sudiciume, dal
vento che sollevava polvere. Per questo sono
molteplici le guarigioni evangeliche di ciechi
(Matteo 9,27-32; 20,29-34; Marco 10,46-52;
Luca 18,35-43; Giovanni 9,1-7).
Ma è facile intuire che, essendo la luce
un simbolo di Dio (1Giovanni 1,5) e di Cristo
(Giovanni 8,12), la liberazione dalla cecità
acquista un senso più profondo, messianico,
tant’è vero che lo stesso Gesù, nel
suo discorso programmatico nella sinagoga
di Nazaret, non esita ad attribuire a sé
il passo isaiano secondo il quale la sua
missione comprendeva anche il ridare «la
vista ai ciechi» (Luca 4,18), impegno che ribadirà
come proprio e specifico ai discepoli
del Battista venuti a interrogarlo come
Messia (Matteo 11,5).
L’episodio del cieco di Betsaida – a causa
del contesto che contiene subito dopo la
confessione di Pietro, il quale proclama Gesù
come il Cristo, ma che registra anche le
incertezze della folla per la quale Gesù è il
Battista o Elia o uno dei profeti redivivi – potrebbe
anche comprendere un’allusione alla
difficoltà nel “vedere” della fede. Essa
può attraversare una fase preparatoria,
quella appunto che intuisce confusamente
in Gesù un profeta che ritorna sulla scena
di Israele. Ma alla fine raggiunge la piena luce,
come accade a Pietro che, secondo Marco
(8,29), vede in lui “il Cristo”, ossia il Messia,
e secondo Matteo (16,16) ancora di più:
«il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
Pubblicato il 15 ottobre 2012 - Commenti (1)
08
ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).
"Se uno dichiara
al padre
o alla madre:
«È korbàn!»,
cioè offerta
a Dio, non
gli consentite
di fare più nulla
per il padre
o la madre."
(Marco 7,11-12)
Questa frase enigmatica è inserita all’interno
di una polemica che Gesù sta intessendo
con alcuni farisei e scribi, venuti
da Gerusalemme in Galilea per verificare
e censurare l’insegnamento e il comportamento
del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:
ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano
le norme della purità rituale sancita dalla
tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando
di ipocrisia i suoi contestatori attraverso
un caso concreto, quello appunto del korbàn,
termine aramaico che indica l’“offerta”
sacra destinata da un fedele al tempio.
Il procedimento era semplice: quando un
ebreo dichiarava formalmente che una somma
di denaro o un altro bene era korbàn, cioè
consacrato per il tempio, quella cifra o quella
realtà non era più disponibile per altre finalità,
secondo quanto affermava una prescrizione
della tradizione giudaica presente nella
Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni
che regolavano la prassi dei fedeli
ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate
in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che
aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale
in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.
Gesù presenta una scandalosa applicazione
di questa norma specifica. Se un ebreo
vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento
dei genitori anziani, può decidere di assumere
una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo
korbàn per il tempio, così che non
ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà
libero dall’obbligo filiale. Ovviamente
l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò
ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado
questo voto restava solo formale e, quindi,
fittizio e non comportava una reale donazione,
ma era soltanto un mezzo estrinseco
per evadere quell’obbligo morale.
I maestri, scribi e dottori della Legge, erano
consapevoli dell’immoralità di un simile
comportamento, ma consideravano lo stesso
valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la
perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale
al cuore della Bibbia, lacerando il velo
ipocrita della casistica e proclama il primato
del Comandamento del Decalogo: «Onora
tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove
quell’“onorare” comportava un impegno
operoso di rispetto, di tutela e di sostegno
della vita familiare (si legga sul tema l’intenso
paragrafo di Siracide 3,1-16).
La conclusione che Cristo appone alla sua
polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento
fondamentale della vera religiosità:
«Voi in questo modo annullate la parola di
Dio con la tradizione che avete tramandato
voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta
una norma umana, a un comandamento morale
si sostituisce un precetto legale, alla limpidità
della spiritualità biblica subentra la meschinità
dell’interesse privato, anche se ammantato
di autorizzazioni ufficiali.
Ritorna anche in questo evento della vita di
Gesù l’afflato della fede profetica che impediva
al legalismo e al ritualismo di soffocare
l’anima profonda della religione biblica.
L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia
e carità debbono sempre avere il primato
sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.
Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)
01
ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).
"Tutti mangiarono a sazietà…
Quelli che avevano mangiato
i pani erano cinquemila uomini."
(Marco 6,44)
Questa volta affrontiamo una questione
che potrà sembrare secondaria.
Ci interessiamo dei numeri
nei cui confronti il mondo semitico (ma
non solo) non si comporta con criteri solo
quantitativi, come accade ora a noi, ma
soprattutto qualitativi. Anche chi non ha
una grande assuefazione con la Bibbia sa
che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno
spesso valore simbolico e sono segni
di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,
al riguardo, è emblematica: tra cardinali,
ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!
E tutti citano quel passo in cui si afferma
che «il numero della Bestia è 666» (13,18),
che è multiplo del 6 e somma di multipli
del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”
(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non
dire poi che – secondo l’antica scienza della
“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche
hanno un valore numerico – quel
666 può essere la trascrizione “cifrata” del
nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN
QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +
S 60 + R 200 = 666.
Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto
con l’indicazione dei fruitori della
prima moltiplicazione dei pani secondo
Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo
parallelo, aggiunge: «senza contare le
donne e i bambini» (14,21). Marco per la
seconda moltiplicazione dei pani riduce
il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato
da Matteo (15,38), sempre con la
precisazione riguardante donne e bambini
che nell’antico Vicino Oriente non erano
un soggetto giuridico in senso stretto
e, quindi, non entravano nel computo.
Qualche perplessità nasce su questa folla
enorme, tenendo conto che la Galilea era
una regione limitata e Gesù si fermava a
parlare in piccole rade del lago di Tiberiade
o su prati molto ristretti con gruppi locali
abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista
parla di una suddivisione «in gruppi
di 100 e 50» persone (6,40).
Effettivamente bisogna notare che il
numero 1.000 era spesso adottato per
designare semplicemente una grande
quantità difficile da contare, oppure acquistava
il valore simbolico dell’immensità
e persino dell’infinito: Dio, ad esempio
perdona e ama per «mille generazioni»
(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo
della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di
persone. Tra l’altro, è curioso notare che
il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica
anche il “bue” che potrebbe essere
l’unità di misura alimentare per un gruppo
clanico o familiare esteso, come lo era
allora la famiglia patriarcale.
Certo, in alcuni casi siamo in presenza
di numeri reali o almeno legati a dati
documentari, come accade nei censimenti
di Israele nel deserto che aprono
il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,
riflettono cifre del periodo in cui il popolo
ebraico era stanziato nella terra promessa,
con probabili ritocchi simbolici, soprattutto
quando si parla delle «migliaia
di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),
designazione riservata ai vari clan. Reali
sono, in buona parte, i dati numerici allegati
dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi
in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati
da Babilonia. È, però, indubbio che la
trasmissione stessa di simili dati nei vari
codici biblici a noi giunti ha subìto spesso
variazioni e incertezze.
Rimane, comunque, fermo il primato
simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il
caso – nel racconto della moltiplicazione
dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo
caso, come i dodici apostoli o le tribù
ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni
della terra di Canaan (Atti 13,19) o i
sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana
(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e
l’abbondanza sono tipiche del banchetto
messianico.
Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)
24
set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.
"Aveva dimora fra le
tombe e nessuno riusciva
a tenerlo legato, neanche
con catene... spezzava
le catene e spaccava
i ceppi e nessuno
riusciva a domarlo".
(Marco 5,3-4)
Siamo – stando al racconto di Marco
(5,1-20) – sulla costa orientale
del lago di Tiberiade «nella regione
dei Geraseni» (Matteo parla, invece,
di Gadara, a sud-est dello stesso lago).
Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza
pagana e quindi “impura”. Ecco
emergere questa figura terribile, una
sorta di mostro che vive o in una necropoli,
tra i morti, oppure sui monti desertici
delle alture del Golan. Appare, così,
un altro segno di “impurità” e negatività,
la morte e il deserto. Quando Gesù
interpella lo “spirito impuro” che travolge
quest’uomo, costui risponde: «Mi
chiamo Legione», un altro elemento negativo
perché rimanda all’oppressione
romana e al suo esercito.
Ma non è finita. Quando Gesù decide
di liberare quest’uomo dagli “spiriti
impuri”, essi domandano e ottengono
di entrare in una mandria di porci
là allevati, tipici animali “impuri” per
la tradizione giudaica. A quel punto il
branco «si precipita dal burrone nel
mare, affogando uno dopo l’altro nel
mare». Il mare (in questo caso il lago:
il linguaggio biblico denomina con un
unico termine le grandi distese d’acqua)
è il simbolo del caos e del male.
La sequenza negativa che regge le fila
del racconto è, dunque, impressionante:
Decapoli, pagani, sepolcri, monti
desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,
porci, mare.
Sembra, quindi, di essere in presenza
di una sorta di compendio del male
del mondo, del demoniaco che avvelena
la storia ma anche dell’idolatria,
perché Isaia descrive così gli idolatri:
«Abitano nei sepolcri, passano la notte
in nascondigli, mangiano carne suina e
cibi impuri... bruciano incenso sui morti
e sui colli insultano il Signore»
(65,4.7). Qual è, allora, il significato da
assegnare a questa narrazione, sia nella
sua realtà storica sia nel suo valore
esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto
dall’evangelista, di quello sventurato,
lo delinea come un pazzo furioso:
non si può legarlo perché reagisce brutalmente,
è autolesionista perché si percuote
con pietre, urla in modo sconclusionato
giorno e notte. Una volta sanato
da Gesù è, invece, tratteggiato come
«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).
Fin qui per quanto riguarda l’evento
storico, ossia la guarigione di un malato
mentale, così come Gesù sanerà un
ragazzo epilettico, scendendo dal monte
della Trasfigurazione (9,14-29). Ma
qual è il valore ulteriore che l’evangelista
assegna a questo fatto? La risposta
deve tener conto proprio di tutti gli elementi
negativi che abbiamo prima elencato
e dell’antica convinzione di Israele,
secondo cui le sindromi più gravi
presupponevano una colpa personale
o una possessione demoniaca. La vicenda,
allora, diventa una narrazione
esemplare per celebrare la vittoria di
Cristo sul male in tutte le sue forme:
egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio
del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle
forze oscure, sia fisiche sia morali, che
tormentano la storia umana.
Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)
17
set
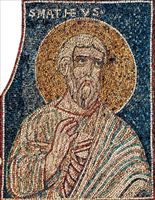
San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.
"Per quelli che
sono fuori tutto
avvienein parabole
affinchéguardino, sì,
ma non vedano,
ascoltino, sì, ma non
comprendano..."
(Marco 4,11-12)
«Così che non si convertano e
venga loro perdonato!»: finisce
con questa fosca clausola
la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo
di Marco riguardo alla funzione delle
parabole che egli sta raccontando. Paradossale
è proprio questa definizione
della finalità delle parabole, espressa
con quell’“affinché” che indica appunto
uno scopo da raggiungere. Forse che
Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,
che è anche il suo modo più comune
di insegnare, per offuscare la
mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli
la conversione («così che non si
convertano») e il relativo perdono dei
peccati («e non venga loro perdonato»)?
La frase, in verità, si basa su una citazione
del profeta Isaia che, nel giorno della
sua vocazione, aveva ricevuto questo
monito: «Rendi insensibile il cuore di
questo popolo, rendilo duro d’orecchi e
acceca i loro occhi, e non veda con gli
occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda
col cuore, né si converta così da
essere guarito!» (6,10).
Dobbiamo proprio partire da questa
citazione per comprendere le dure parole
di Cristo che sembrerebbero smentire
la finalità salvifica della sua predicazione.
È chiaro il contenuto dell’appello rivolto
a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto
degli Israeliti, un fenomeno scontato
e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi
sono in realtà equivalenti a indicativi:
si adotta questa forma per
mostrare quale sarà il risultato della
predicazione profetica, che Dio certamente
non vuole, ma che gli è già nota
ed è inserita nel suo disegno di salvezza.
Questo progetto salvifico, però, continuerà
lo stesso e si attuerà giudicando il peccato
e l’indurimento del cuore e salvando
chi si convertirà e compirà il bene.
L’imperativo non è, quindi, un invito
a operare in quella linea negativa, bensì
è un modo per rappresentare in forma
efficace che neanche il male sfugge
al piano divino, che non esiste una divinità
negativa che si oppone all’unico Signore,
come insegnava il dualismo religioso
(Dio del bene contro il dio del male),
che la libertà umana con le sue scelte
perverse non è ignota al Creatore e
non frustra la sua volontà di salvezza.
Nello stesso libro di Isaia si giunge al
punto di porre anche il male sotto il comando
divino: «Sono io che formo la luce
e le tenebre, faccio il bene e provoco
il male» (45,7). Con questa frase così
aspra si vuole soltanto ricordare che
nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;
anche il male e il peccato possono
essere inquadrati nel suo grande disegno
sull’essere e sull’esistere.
Gesù cita, dunque, questa tesi importante
formulata nello scritto isaiano e
quella “finalità” («affinché...») è di tipo
“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale
espressione «affinché si adempia
la Scrittura che dice...». L’evangelista
ne condivide con Gesù (che rimanda
a Isaia) il contenuto: le parabole,
che dovrebbero essere un luminoso
esempio di rivelazione, diventano un
elemento di ostinazione contro Cristo.
Questo, però, non deve impressionare,
perché Dio – che sa anche dal male trarre
un bene – continuerà lo stesso a compiere
l’insediamento del suo Regno.
È interessante vedere come Matteo
abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù
sostituendo alla finale («affinché...»)
una causale più immediata e chiara
(«perché...»). Il messaggio in parabole di
Gesù non è accolto «perché il cuore di
questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri d’orecchi, hanno
chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).
Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)
10
set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.
"Nella sinagoga
vi era un uomo
posseduto da uno
spirito impuro.
Cominciò
a gridare:
«Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno?
Io so chi tu sei:
il Santo di Dio!»"
(Marco 1,23-24)
Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:
nell’arco di un giorno e nello
spazio di questa cittadina che s’affaccia
sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie
di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge
nella sinagoga locale (quella che Giovanni
inserì come fondale per il celebre discorso
di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso
una persona si alza nell’assemblea, mentre
Gesù sta insegnando con grande autorità, e
gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo
(Marco 1,21-26). Chi travolge
quest’uomo apparentemente normale, facendone
un avversario di Cristo?
In lui agisce un’inattesa presenza specifica,
sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È
una presenza vitale e personale che interloquisce
con Cristo, paradossalmente riconoscendolo
come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come
dotata di una trascendenza e di un’origine
divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il
quale sa di avere come avversario Dio stesso,
presente e operante in Gesù Cristo. Non
possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione
da una malattia grave, come la demenza (Marco
5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito
considereremo e rubricati dagli evangelisti
come possessioni diaboliche.
Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino
Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna
del demoniaco tutto il negativo della storia:
le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli
influssi sociali nefasti, il peccato personale, il
male in generale. Qui, invece, si ha una presenza
personale specifica; è l’incontro con un
essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi
suo avversario; con lui Gesù ingaggia
un duello che si risolve con un comando
efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».
E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido
di sconfitta di Satana. La salvezza non viene
da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni
magiche, ma solo da un ordine autorevole
e operativo di Cristo.
Al centro di questo racconto non c’è, quindi,
lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore
dal male. Il cristianesimo rigetta ogni
forma di dualismo che veda come arbitri della
storia e dell’essere due divinità antitetiche: il
demonio non è il principio del male che combatte
il principio divino del bene. Satana (in
ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è
da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,
la sua presenza dev’essere ridimensionata,
il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un
essere personale che agisce con forza. Certo,
l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,
perché si tratta di un concetto positivo,
usato anche per Dio (ad esempio, le tre
“persone” della Trinità).
Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale
l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi
anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe
essere segno di intimità, di donazione, di
amore. Lo scrittore francese agnostico André
Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:
Io sono colui che non sono». E curiosamente
lo stesso autore concludeva: «Non credo nel
diavolo; ma è proprio quello che il diavolo
spera: che non si creda in lui». A lui farà eco
Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima
astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce
della sua morte».
Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)
30
ago

Cristo in croce di Jean-Baptiste Van Loo (1684-1745). Firenze, Palazzo Pitti.
"Dall'ora sesta
si fece buio
su tutta la terra,
fino all’ora nona."
(Matteo 27,45)
Matteo ha evocato una coreografia di
eventi clamorosi attorno alla morte
di Gesù. Il loro scopo è di presentare
la vicenda finale di Cristo nel suo significato
profondo, “teofanico”, cioè rivelatore
dell’azione divina di salvezza, approdo di
una storia di annunci già offerti dall’Antico
Testamento. È così che l’evangelista convoca
una serie di immagini bibliche per illustrare
il senso autentico e profondo della morte di
Cristo, che si è compiuta in quel pomeriggio
primaverile intorno all’anno 30. Tre sono i segni
introdotti da Matteo.
Il primo è comune anche a Marco e Luca ed
è lo squarcio nel “velo del tempio”, ossia di
quella cortina di porpora, di scarlatto e lino
che nascondeva il Santo dei Santi, la sede
dell’arca dell’alleanza e della presenza di Dio
in mezzo al suo popolo. Facile è intuire il valore
di quel segno: Dio non è più misterioso e
invisibile, ma è visibile in quell’uomo crocifisso,
tant’è vero che il centurione e la sua
scorta esclamano: «Davvero costui era Figlio di
Dio!» (27,54).
Il secondo segno “teofanico” è classico nella
Bibbia, il terremoto accompagnato da
un’eclissi di sole, un evento che in questo caso
non è documentabile storicamente e astronomicamente,
ma il cui valore è simbolico
perché, come accade al Sinai, «tuoni, lampi,
nube oscura» e «il monte che trema molto»
(Esodo 19,16.18) fanno parte della scenografia
dell’ingresso di Dio nell’orizzonte della storia
umana. In tal modo si vuole marcare la trascendenza
e la potenza divina. Il profeta
Amos, per descrivere «il giorno del Signore»,
cioè il suo giudizio sulla storia umana, usa
un’immagine affine: «In quel giorno – oracolo
del Signore Dio – farò tramontare il sole
all’ora terza [mezzodì] e oscurerò la terra in
pieno giorno» (8,9).
Infine, il terzo segno, il più importante per
spiegare il valore ultimo della morte di Gesù:
«I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi
morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri,
dopo la sua risurrezione, entrarono nella città
santa e apparvero a molti» (27,52-53). Significativo
è l’inciso «dopo la sua risurrezione
»: la morte e la risurrezione di Cristo segnano
l’inizio del trionfo sulla morte per l’intera
umanità. I membri del popolo di Dio («i
santi morti») sono uniti alla vittoria di Gesù
sulla morte: le loro tombe sono spalancate,
i corpi risorti entrano nella «città santa»,
cioè Gerusalemme nuova e perfetta, mentre
la loro “apparizione” è la testimonianza della
realtà della vittoriosa risurrezione di Cristo
che ha preceduto la loro.
In conclusione, la narrazione matteana della
morte di Gesù non dev’essere letta in modo
cronachistico, ma nella sua densità religiosa.
Certo, l’evangelista offre molti dati storici
e spaziali su quella morte, ma vuole che i
suoi lettori ne colgano il significato profondo,
l’unicità assoluta, la dimensione teologica.
Ed egli lo fa ricorrendo a quei segni biblici
del velo, della tenebra, dei sepolcri aperti e
dei giusti risorti. Quella morte, infatti, non è
solo un evento storico, ma è l’ingresso
della divinità nella caducità
dell’esistenza umana per
trasformarla e introdurla
all’abbraccio con
Dio e l’eterno.
Pubblicato il 30 agosto 2012 - Commenti (4)
23
ago

Gesù davanti a Pilato, affresco di scuola cassinese. Sant’Angelo in Formis, Capua.
"Tutto il popolo esclamò:
«Il suo sangue
ricada su di noi
e sui nostri figli».
(Matteo 27,25)
Una vasta bibliografia è fiorita attorno al
duplice processo subito da Gesù, quello
presso il tribunale supremo giudaico, il
Sinedrio, e la successiva istanza imperiale
presso il governatore romano Ponzio Pilato. I
Vangeli, nella loro relazione di quegli eventi,
riflettono anche il contesto storico in cui la comunità
cristiana allora viveva, con evidenti
tensioni rispetto all’ebraismo da cui essa proveniva.
Questo aspetto specifico è percepibile
nella redazione matteana di quegli atti: essa è
protesa a marcare le responsabilità del Sinedrio,
attenuando quelle – decisive per la
sentenza finale – del procuratore romano.
Significativi, al riguardo, sono due elementi
evocati solo da questo evangelista: l’intervento
della moglie di Pilato, «turbata in sogno
a causa dell’uomo giusto» Gesù (27,19), e
la lavanda delle mani, gesto in realtà biblico,
scandito da una dichiarazione di Pilato:
«Non sono responsabile di questo sangue». Si
spiega, così, l’accento spostato sul Sinedrio e
sul popolo ebraico, come appare nella frase
veemente che abbiamo posto sotto la nostra
attenzione. È evidente che con essa Matteo, il
cui Vangelo era indirizzato a cristiani di origine
giudaica, vuole ormai segnare fortemente
il distacco dalla Sinagoga e mostrare l’apertura
della Chiesa verso il mondo pagano.
Sappiamo, d’altronde, che i Vangeli non
sono documenti storiografici in senso stretto:
pur fondandosi su avvenimenti testimoniali
e memorie storiche, essi offrono una
molteplice rilettura teologica della figura,
delle vicende e delle parole di Gesù di Nazaret.
Non per nulla sono quattro e hanno alla
base autori e situazioni originarie differenti.
Dal punto di vista storiografico, è difficile
essere drastici rispetto alle responsabilità
della condanna a morte di Gesù. Certamente
la pena di morte fu irrogata solo da chi aveva
il potere giuridico di emetterne la sentenza,
cioè il tribunale romano.
Non possiamo, però, ignorare che il Sinedrio
aveva rubricato la colpa di Gesù da religiosa
(la bestemmia) a politica (la ribellione
a Cesare) per eliminare una figura imbarazzante
per la classe dirigente religiosa e politica
giudaica di allora. Si spiega così la frase
della folla evocata da Matteo, secondo
un’espressione biblica tradizionale per condannare
un delitto o una persona pericolosa,
assumendone la responsabilità (si veda 2Samuele
1,16 e 3,29). Questo, tuttavia, non può
assolutamente autorizzare – come purtroppo
è avvenuto con l’antisemitismo di matrice cristiana
– a usare la frase matteana per sostenere
l’assurda accusa di “deicidio” per il popolo
ebraico (e neppure per i Romani).
Chiaro ed esplicito è stato il concilio Vaticano
II quando ha affermato: «Sebbene le autorità
ebraiche con i propri seguaci si siano adoperate
per la morte di Cristo, tuttavia quanto
è stato commesso durante la sua Passione
non può essere imputato né indistintamente
a tutti gli Ebrei allora viventi né agli
Ebrei del nostro tempo» (Nostra aetate, n.
4). A questo, poi, si aggiunge il legame radicale
del cristianesimo con Israele, affermato
dallo stesso san Paolo nelle pagine appassionate
dei capp. 9-11 della Lettera ai Romani o
dalla frase suggestiva del Gesù di Giovanni:
«La salvezza viene dai Giudei» (4,22).
Pubblicato il 23 agosto 2012 - Commenti (2)
16
ago

Bacio di Giuda, copia del mosaico della basilica di San Marco, Venezia.
"Giuda si avvicinò
a Gesù e disse: «Salve, Rabbì».
E lo baciò.
Gesù gli disse:
«Amico, per
questo sei qui!».
(Matteo 26,49-50)
In quella notte fosca, nell’orto degli Ulivi,
detto in aramaico Getsemani (“frantoio per
olive”), s’avanza Giuda, il discepolo soprannominato
“Iscariota”, forse “uomo di Kariot”,
un villaggio meridionale della Terra
Santa, oppure – secondo le varie ipotesi interpretative
formulate dagli studiosi – deformazione
del termine latino sicarius, con cui i Romani
bollavano i ribelli al loro potere, o ancora
’ish-karja’, “uomo della falsità”, forse
un soprannome negativo assegnatogli successivamente.
Il celebre gesto del bacio che egli
compie è divenuto un emblema del tradimento,
e Gesù, secondo il Vangelo di Luca,
reagisce tristemente: «Giuda, con un bacio
tradisci il Figlio dell’uomo?» (22,48).
Matteo, invece, registra solo una reazione
secca da parte di Cristo. In greco si ha soltanto
ef’ ho párei, che significa: «Per questo sei
qui!», in pratica, «fa’ quello che hai deciso di
fare». Ma questa frase, simile a un soffio, è
introdotta da un amaro hetáire, “amico”.
L’evangelista, però, riferirà uno sbocco inatteso
di quel gesto, a distanza di poche ore da
questo scarno dialogo tra l’ex discepolo e il
suo Maestro: Giuda, infatti, restituito ai mandanti
il prezzo del tradimento, travolto dal rimorso,
s’impiccherà (27,5).
Forse egli aveva vissuto una delusione interiore
rispetto al sogno di diventare il seguace
del Messia politico liberatore dal potere
oppressivo imperiale e per questo aveva tradito,
ritrovandosi però alla fine interiormente
sconvolto.
Noi ora ci poniamo una domanda
più teologica. Se il tradimento era iscritto
nel disegno di Dio che comprendeva la morte
salvifica del Figlio, quale responsabilità
poteva ricadere su chi ne doveva essere lo
strumento di attuazione?
Non è forse vero
che Gesù aveva dichiarato che «nessuno [dei
discepoli] sarebbe andato perduto tranne il
figlio della perdizione, perché si adempisse
la Scrittura» (Giovanni 17,12)?
La questione è delicata: da un lato, c’è la libertà
efficace di Dio che opera nella storia e
nel mondo; d’altro lato, c’è la libertà della
persona umana di Giuda. Questa seconda libertà
è stata sollecitata in Giuda da Satana,
come aveva ribadito lo stesso Gesù: «Non ho
forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi
è un diavolo!», si legge nel Vangelo di Giovanni
(6,70), e lo stesso evangelista nota che, dopo
l’ultima cena con Gesù nel Cenacolo, «Satana
entrò in Giuda...; il diavolo gli aveva messo
in cuore di tradire» (13,2.27). E aggiungerà
che alla base del tradimento c’era la cupidigia
del denaro (12,4-6). La volontà di Giuda
si era, quindi, esercitata liberamente, cedendo
alla tentazione diabolica.
Come, invece, si è manifestata la libertà
di Dio, espressa nella frase «perché si adempisse
la Scrittura» usata da Gesù per collocare
l’evento del tradimento in un altro disegno
superiore? Questa formula vuole semplicemente
indicare che anche la libertà
umana con le sue follie e vergogne può essere
inserita in un disegno divino superiore.
Giuda opta coscientemente e responsabilmente
per il tradimento aderendo a Satana,
e Dio inserisce questo atto umano infame
nel suo progetto libero ed efficace di redenzione.
Dio non è, quindi, preso in contropiede
dalla scelta del traditore; egli la rispetta e
non la blocca, ma la riconduce all’interno
del disegno salvifico che si attuerà proprio
con la morte di Cristo.
Pubblicato il 16 agosto 2012 - Commenti (2)
09
ago

Giudizio Finale (1289-93), particolare dei serafini, affresco di Pietro Cavallini (1240 ca.-1320 ca.). Roma, Santa Cecilia in Trastevere.
"Quanto a quel
giorno e a
quell'ora
nessuno lo sa, né
gli angeli
del cielo, né il
Figlio ma solo
il Padre".
(Matteo 24,36)
Partiamo da una domanda iniziale che i
discepoli rivolgono a Gesù. Egli, sostando
davanti al monumentale tempio gerosolimitano
eretto da Erode, aveva annunziato
la futura rovina di quell’edificio.
I discepoli,
allora, gli avevano chiesto: «Di’ a noi
quando accadranno queste cose e quale sarà
il segno della tua venuta e della fine del mondo
» (Matteo 24,3). È evidente che, nel loro quesito,
essi intrecciano eventi diversi tra loro: la
distruzione del tempio da parte dei Romani
nel 70, la nuova venuta di Cristo giudice della
storia e la fine del mondo. Si concentrano qui
alcuni interrogativi che hanno tormentato la
Chiesa delle origini e che hanno vari riflessi
nel Nuovo Testamento (si leggano, ad esempio,
le Lettere di Paolo ai Tessalonicesi o il libro
dell’Apocalisse o la Seconda Lettera di Pietro
nella finale del cap. 3 e così via).
Queste domande sono usate da Matteo come
cornice per il cosiddetto “discorso escatologico”,
il quinto e ultimo intervento ampio
di Gesù, presente nei capp. 24-25 di quel Vangelo.
Il termine “escatologico” è di matrice
greca e indica le “realtà ultime”, cioè la fine
della storia, ma anche il fine di tutto l’essere.
Non si tratta, infatti, di una dissoluzione
nel nulla ma di una redenzione, di una salvezza,
di una nuova creazione («cielo nuovo
e terra nuova», Apocalisse 21,1), comprendente
il giudizio divino discriminante tra bene e
male (si legga Matteo 25,31-46, una pagina
memorabile che vede Cristo protagonista di
questo atto ultimo della storia umana).
Il discorso escatologico di Cristo non vuole
descrivere i fenomeni fisici o gli eventi terminali
che sigleranno la fine del mondo, anche se in
apparenza le immagini usate sembrano inclinare
in questa linea.
In realtà, si tratta di simboli
desunti da una letteratura popolare nel
giudaismo di quei secoli, presente anche
nella Bibbia col libro di Daniele, e denominata
“apocalittica”. Il termine di genesi greca designa
una “rivelazione” (si pensi all’Apocalisse
di Giovanni): essa ha come meta l’apertura simbolica
del sipario sul destino ultimo dell’essere
e dell’esistere. Proprio perché essa si affaccia su
un ignoto tenebroso, questa letteratura ama segni,
visioni, scene che recano impresse sensazioni
di terrore o di indecifrabilità.
Cristo ricorre a questo apparato non per
elaborare previsioni su quell’evento estremo,
bensì per creare tensione e impegno
nei confronti del regno di Dio, già inaugurato
con la sua venuta ma destinato a raggiungere
una meta di pienezza futura, un po’ come
aveva fatto balenare nella parabola del
granello di senape che cresce fino a diventare
un albero (Matteo 13,31-32).
In questa luce
si comprende la frase sorprendente che abbiamo
ritagliato da quel discorso. A Gesù poco
interessa fare oroscopi sulla fine del mondo
oppure sugli antefatti storici: essi sono certamente
inseriti nel piano salvifico divino.
Egli, invece, nella sua esistenza storica e
umana si interessa solo di ciò che riguarda
la sua missione, ossia instaurare le basi del
regno di Dio, un progetto di salvezza, di liberazione,
di amore che fiorirà pienamente in
quell’eternità, destinata a subentrare «a
quel giorno e a quell’ora» della fine che il
Padre celeste ha disegnato nel suo piano generale
di creazione e di redenzione. In questa
frase di Gesù brilla, quindi, la sua umanità
reale e non fittizia.
La divinità, alla quale
egli partecipa come Figlio di Dio, sarà invece
svelata nella sua risurrezione e nel suo ritorno
al Padre.
Pubblicato il 09 agosto 2012 - Commenti (0)
02
ago

Sacra parentela, dipinto originario della Germania, circa 1500. Philadelphia, Museum of Art.
"Gesù chiese
ai farisei: «Che
cosa pensate
del Cristo?
Di chi è figlio?».
Gli risposero:
«Di Davide»".
(Matteo 22,41-42)
Questa volta non sono i suoi avversari
a punzecchiare Gesù, come
accade ripetutamente nella pagina
del capitolo 22 di Matteo, una pagina
costellata di “controversie”, ossia di
polemiche con farisei e sadducei. Ora è
lui stesso che provoca i farisei riuniti
in un’assemblea, rivolgendo loro il quesito
che abbiamo citato, apparentemente
banale. Non era, infatti, noto a
tutti i lettori della Bibbia che il Messia
sarebbe disceso dal filo genealogico davidico?
Ricordiamo che la parola “Cristo”
è la versione greca dell’ebraico
“Messia” (Mashiah) che significa “consacrato”,
e che “figlio” è usato spesso in
senso lato per indicare un discendente.
Dov’è, dunque, la difficoltà?
Essa è da cercare nel prosieguo della
discussione. Gesù, infatti, mette sul tappeto
del dibattito un celebre Salmo messianico,
il 110, ritenuto opera di Davide
come si evince dal titolo che gli era stato
apposto: «Di Davide. Salmo». L’inno,
composto dal famoso sovrano considerato
appunto dalla tradizione come
l’antenato del Messia, «mosso dallo Spirito
» (22,43), inizia con un oracolo divino
che è così introdotto: «Disse il Signore
[Yhwh Dio] al mio Signore [il re Messia]
». Segue l’oracolo: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici sotto
i tuoi piedi». Davide, quindi, chiama il
Messia «mio signore». Facile è l’obiezione
di Cristo: «Se dunque lo chiama “Signore”
come può essere suo figlio?»
(22,44-45). Se il Messia-Cristo è “figlio
di Davide”, come può Davide definirlo
suo “Signore” e quindi a lui superiore?
I farisei si trovano impastoiati in
una disputa di taglio rabbinico, un genere
nel quale peraltro eccellevano.
Gesù li avviluppa nella stessa rete che essi
più di una volta avevano teso contro
di lui con i loro quesiti. A questo punto,
però, ci si attenderebbe di vedere come
Gesù – qui raffigurato nella veste di un
rabbí giudaico – riesca a risolvere la contraddizione
tra un Messia contemporaneamente
figlio e Signore di Davide, secondo
l’analisi appena fatta del Salmo
110. La conclusione di Matteo è spiazzante:
«Nessuno era in grado di rispondergli
e, da quel giorno, nessuno osò
più interrogarlo» (22,46). Marco, che ambienta
questa scena nell’area del tempio
di Gerusalemme, senza introdurre i
farisei come interlocutori, conclude semplicemente:
«la folla numerosa lo ascoltava
volentieri» (12,37).
La risposta a quell’apparente contraddizione
è ovviamente possibile solo
in sede cristiana. Per il giudaismo,
infatti, il Messia rimane creatura umana
e come tale non potrà essere definito
“Signore”. Nel cristianesimo il Cristo
ha certamente una reale dimensione
storica e, quindi, è ancorato nella
sua umanità a una discendenza, quella
davidica, attestata dalla genealogia
che lo stesso Matteo pone in apertura
al suo Vangelo: «Genealogia di Gesù
Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo
» (1,1). Egli è, dunque, realmente «figlio
[discendente] di Davide», legato alla
linea della promessa messianica
(2Samuele 7; Salmo 89). Ma contemporaneamente
è figlio di Dio e, in questa
luce, è “Signore” di Davide. Il mistero
centrale del cristiano, l’Incarnazione,
risolve dunque anche l’enigma del Salmo
110, posto da Gesù all’attenzione
dei farisei.
Pubblicato il 02 agosto 2012 - Commenti (2)
26
lug

Simone Pignoni (1611-1698), Rut e Booz. Firenze, Collezione Cisbani.
"Alla risurrezione, di
quale dei sette quella
donna sarà moglie?
Tutti infatti l’hanno
avuta in moglie!"
(Matteo 22,28)
Se si va a cercare su un dizionario
biblico la parola “levirato” (dal latino
levir, “cognato”) si trova più
o meno una definizione di questo tipo:
«Prassi giuridica dell’antichità ebraica e
di altri popoli, secondo la quale se un uomo
sposato decedeva senza figli, il fratello
più giovane ne doveva sposare la vedova
per assicurare una discendenza al
defunto: il nome del morto e la sua eredità
sarebbero stati assegnati al primogenito
di questa nuova unione». Nell’Antico
Testamento sono tre i testi che presentano
tale istituto. I primi due riguardano il
primogenito del patriarca Giuda di nome
Er, morto precocemente (Genesi
38,6-11), e Booz che prese in moglie Rut,
sposa del defunto Elimelek, essendo suo
unico parente (Rut 1,11; 4,5).
In pratica, da questi due testi emerge
che il cognato (o il parente prossimo,
in caso di assenza di cognati) doveva
sposare la vedova di suo fratello, così
da poter assicurare un erede. Il terzo
testo è, invece, squisitamente giuridico
e offre un’articolazione più complessa
dell’obbligo con una serie di specificazioni,
limitazioni ed eccezioni che non
è il caso di puntualizzare in questa nostra
trattazione (Deuteronomio 25,5-10).
Il nostro compito è, infatti, quello di
spiegare il caso limite addotto dai Sadducei,
una corrente conservatrice del
giudaismo del tempo di Cristo, proposto
a Gesù per metterlo in imbarazzo.
Essi prospettano una catena di levirati
nei confronti di una sola donna: sette
fratelli subentrano in matrimoni
successivi, morendo però tutti prima
di aver assicurato una discendenza alla
vedova e, quindi, al loro primo fratello
defunto.
Il paradosso fittizio è introdotto per
costringere Gesù a schierarsi con loro
contro i farisei – l’altra corrente giudaica
avversaria – negando la risurrezione
che questi ultimi sostenevano come dottrina
di fede. Infatti, sogghignando, alla
fine gli domandano: «Alla risurrezione,
di quale dei sette la donna sarà moglie?
». Cristo, nella sua risposta, non cade
nel tranello e replica volando alto:
«Alla risurrezione non si prende né marito
né moglie, ma si è come gli angeli
del cielo» (22,30). Egli nega, così, una
lettura “materialistica” della risurrezione.
E aggiunge una motivazione teologica
ulteriore, citando un passo
dell’incontro di Mosè con il Signore al
roveto ardente del Sinai: «Io sono il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.
Non è il Dio dei morti ma dei viventi!
» (22,32; cfr. Esodo 3,6).
Dio non si lega a cadaveri, ma a esseri
viventi ai quali apre un orizzonte di
vita oltre la morte secondo categorie
differenti rispetto a quelle meramente
“carnali”, basate sulla nostra storia che
si muove secondo le coordinate dello
spazio e del tempo. Si tratta di un nuovo
ordine di rapporti, di una nuova
creazione, di un orizzonte nel quale i
vincoli parentali e sociali sono trasfigurati.
Queste parole di Gesù avevano
conquistato quel grande filosofo e
scienziato credente che fu Blaise Pascal.
A partire dal 1654 fino alla morte
(1662) egli portò sempre con sé un foglio,
cucito nella fodera del farsetto, intitolato
“Fuoco”, e scoperto alla morte
del pensatore da un domestico.
Eccone il testo modulato sulle parole
di Gesù, commentate liberamente da
Pascal: «Dio d’Abramo, Dio d’Isacco,
Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei
dotti. Certezza, certezza. Sentimento.
Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo. Dio mio
e Dio vostro. Il tuo Dio sarà il mio Dio.
Oblio del mondo e di tutto fuorché di
Dio. Egli non si trova se non per le vie
indicate dal Vangelo».
Pubblicato il 26 luglio 2012 - Commenti (2)
|
|