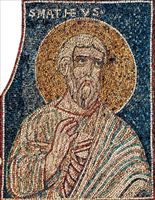
San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.
"Per quelli che
sono fuori tutto
avvienein parabole
affinchéguardino, sì,
ma non vedano,
ascoltino, sì, ma non
comprendano..."
(Marco 4,11-12)
«Così che non si convertano e
venga loro perdonato!»: finisce
con questa fosca clausola
la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo
di Marco riguardo alla funzione delle
parabole che egli sta raccontando. Paradossale
è proprio questa definizione
della finalità delle parabole, espressa
con quell’“affinché” che indica appunto
uno scopo da raggiungere. Forse che
Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,
che è anche il suo modo più comune
di insegnare, per offuscare la
mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli
la conversione («così che non si
convertano») e il relativo perdono dei
peccati («e non venga loro perdonato»)?
La frase, in verità, si basa su una citazione
del profeta Isaia che, nel giorno della
sua vocazione, aveva ricevuto questo
monito: «Rendi insensibile il cuore di
questo popolo, rendilo duro d’orecchi e
acceca i loro occhi, e non veda con gli
occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda
col cuore, né si converta così da
essere guarito!» (6,10).
Dobbiamo proprio partire da questa
citazione per comprendere le dure parole
di Cristo che sembrerebbero smentire
la finalità salvifica della sua predicazione.
È chiaro il contenuto dell’appello rivolto
a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto
degli Israeliti, un fenomeno scontato
e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi
sono in realtà equivalenti a indicativi:
si adotta questa forma per
mostrare quale sarà il risultato della
predicazione profetica, che Dio certamente
non vuole, ma che gli è già nota
ed è inserita nel suo disegno di salvezza.
Questo progetto salvifico, però, continuerà
lo stesso e si attuerà giudicando il peccato
e l’indurimento del cuore e salvando
chi si convertirà e compirà il bene.
L’imperativo non è, quindi, un invito
a operare in quella linea negativa, bensì
è un modo per rappresentare in forma
efficace che neanche il male sfugge
al piano divino, che non esiste una divinità
negativa che si oppone all’unico Signore,
come insegnava il dualismo religioso
(Dio del bene contro il dio del male),
che la libertà umana con le sue scelte
perverse non è ignota al Creatore e
non frustra la sua volontà di salvezza.
Nello stesso libro di Isaia si giunge al
punto di porre anche il male sotto il comando
divino: «Sono io che formo la luce
e le tenebre, faccio il bene e provoco
il male» (45,7). Con questa frase così
aspra si vuole soltanto ricordare che
nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;
anche il male e il peccato possono
essere inquadrati nel suo grande disegno
sull’essere e sull’esistere.
Gesù cita, dunque, questa tesi importante
formulata nello scritto isaiano e
quella “finalità” («affinché...») è di tipo
“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale
espressione «affinché si adempia
la Scrittura che dice...». L’evangelista
ne condivide con Gesù (che rimanda
a Isaia) il contenuto: le parabole,
che dovrebbero essere un luminoso
esempio di rivelazione, diventano un
elemento di ostinazione contro Cristo.
Questo, però, non deve impressionare,
perché Dio – che sa anche dal male trarre
un bene – continuerà lo stesso a compiere
l’insediamento del suo Regno.
È interessante vedere come Matteo
abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù
sostituendo alla finale («affinché...»)
una causale più immediata e chiara
(«perché...»). Il messaggio in parabole di
Gesù non è accolto «perché il cuore di
questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri d’orecchi, hanno
chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).
Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)