08
ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).
"Se uno dichiara
al padre
o alla madre:
«È korbàn!»,
cioè offerta
a Dio, non
gli consentite
di fare più nulla
per il padre
o la madre."
(Marco 7,11-12)
Questa frase enigmatica è inserita all’interno
di una polemica che Gesù sta intessendo
con alcuni farisei e scribi, venuti
da Gerusalemme in Galilea per verificare
e censurare l’insegnamento e il comportamento
del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:
ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano
le norme della purità rituale sancita dalla
tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando
di ipocrisia i suoi contestatori attraverso
un caso concreto, quello appunto del korbàn,
termine aramaico che indica l’“offerta”
sacra destinata da un fedele al tempio.
Il procedimento era semplice: quando un
ebreo dichiarava formalmente che una somma
di denaro o un altro bene era korbàn, cioè
consacrato per il tempio, quella cifra o quella
realtà non era più disponibile per altre finalità,
secondo quanto affermava una prescrizione
della tradizione giudaica presente nella
Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni
che regolavano la prassi dei fedeli
ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate
in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che
aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale
in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.
Gesù presenta una scandalosa applicazione
di questa norma specifica. Se un ebreo
vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento
dei genitori anziani, può decidere di assumere
una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo
korbàn per il tempio, così che non
ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà
libero dall’obbligo filiale. Ovviamente
l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò
ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado
questo voto restava solo formale e, quindi,
fittizio e non comportava una reale donazione,
ma era soltanto un mezzo estrinseco
per evadere quell’obbligo morale.
I maestri, scribi e dottori della Legge, erano
consapevoli dell’immoralità di un simile
comportamento, ma consideravano lo stesso
valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la
perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale
al cuore della Bibbia, lacerando il velo
ipocrita della casistica e proclama il primato
del Comandamento del Decalogo: «Onora
tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove
quell’“onorare” comportava un impegno
operoso di rispetto, di tutela e di sostegno
della vita familiare (si legga sul tema l’intenso
paragrafo di Siracide 3,1-16).
La conclusione che Cristo appone alla sua
polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento
fondamentale della vera religiosità:
«Voi in questo modo annullate la parola di
Dio con la tradizione che avete tramandato
voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta
una norma umana, a un comandamento morale
si sostituisce un precetto legale, alla limpidità
della spiritualità biblica subentra la meschinità
dell’interesse privato, anche se ammantato
di autorizzazioni ufficiali.
Ritorna anche in questo evento della vita di
Gesù l’afflato della fede profetica che impediva
al legalismo e al ritualismo di soffocare
l’anima profonda della religione biblica.
L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia
e carità debbono sempre avere il primato
sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.
Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)
01
ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).
"Tutti mangiarono a sazietà…
Quelli che avevano mangiato
i pani erano cinquemila uomini."
(Marco 6,44)
Questa volta affrontiamo una questione
che potrà sembrare secondaria.
Ci interessiamo dei numeri
nei cui confronti il mondo semitico (ma
non solo) non si comporta con criteri solo
quantitativi, come accade ora a noi, ma
soprattutto qualitativi. Anche chi non ha
una grande assuefazione con la Bibbia sa
che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno
spesso valore simbolico e sono segni
di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,
al riguardo, è emblematica: tra cardinali,
ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!
E tutti citano quel passo in cui si afferma
che «il numero della Bestia è 666» (13,18),
che è multiplo del 6 e somma di multipli
del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”
(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non
dire poi che – secondo l’antica scienza della
“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche
hanno un valore numerico – quel
666 può essere la trascrizione “cifrata” del
nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN
QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +
S 60 + R 200 = 666.
Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto
con l’indicazione dei fruitori della
prima moltiplicazione dei pani secondo
Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo
parallelo, aggiunge: «senza contare le
donne e i bambini» (14,21). Marco per la
seconda moltiplicazione dei pani riduce
il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato
da Matteo (15,38), sempre con la
precisazione riguardante donne e bambini
che nell’antico Vicino Oriente non erano
un soggetto giuridico in senso stretto
e, quindi, non entravano nel computo.
Qualche perplessità nasce su questa folla
enorme, tenendo conto che la Galilea era
una regione limitata e Gesù si fermava a
parlare in piccole rade del lago di Tiberiade
o su prati molto ristretti con gruppi locali
abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista
parla di una suddivisione «in gruppi
di 100 e 50» persone (6,40).
Effettivamente bisogna notare che il
numero 1.000 era spesso adottato per
designare semplicemente una grande
quantità difficile da contare, oppure acquistava
il valore simbolico dell’immensità
e persino dell’infinito: Dio, ad esempio
perdona e ama per «mille generazioni»
(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo
della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di
persone. Tra l’altro, è curioso notare che
il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica
anche il “bue” che potrebbe essere
l’unità di misura alimentare per un gruppo
clanico o familiare esteso, come lo era
allora la famiglia patriarcale.
Certo, in alcuni casi siamo in presenza
di numeri reali o almeno legati a dati
documentari, come accade nei censimenti
di Israele nel deserto che aprono
il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,
riflettono cifre del periodo in cui il popolo
ebraico era stanziato nella terra promessa,
con probabili ritocchi simbolici, soprattutto
quando si parla delle «migliaia
di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),
designazione riservata ai vari clan. Reali
sono, in buona parte, i dati numerici allegati
dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi
in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati
da Babilonia. È, però, indubbio che la
trasmissione stessa di simili dati nei vari
codici biblici a noi giunti ha subìto spesso
variazioni e incertezze.
Rimane, comunque, fermo il primato
simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il
caso – nel racconto della moltiplicazione
dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo
caso, come i dodici apostoli o le tribù
ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni
della terra di Canaan (Atti 13,19) o i
sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana
(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e
l’abbondanza sono tipiche del banchetto
messianico.
Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)
24
set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.
"Aveva dimora fra le
tombe e nessuno riusciva
a tenerlo legato, neanche
con catene... spezzava
le catene e spaccava
i ceppi e nessuno
riusciva a domarlo".
(Marco 5,3-4)
Siamo – stando al racconto di Marco
(5,1-20) – sulla costa orientale
del lago di Tiberiade «nella regione
dei Geraseni» (Matteo parla, invece,
di Gadara, a sud-est dello stesso lago).
Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza
pagana e quindi “impura”. Ecco
emergere questa figura terribile, una
sorta di mostro che vive o in una necropoli,
tra i morti, oppure sui monti desertici
delle alture del Golan. Appare, così,
un altro segno di “impurità” e negatività,
la morte e il deserto. Quando Gesù
interpella lo “spirito impuro” che travolge
quest’uomo, costui risponde: «Mi
chiamo Legione», un altro elemento negativo
perché rimanda all’oppressione
romana e al suo esercito.
Ma non è finita. Quando Gesù decide
di liberare quest’uomo dagli “spiriti
impuri”, essi domandano e ottengono
di entrare in una mandria di porci
là allevati, tipici animali “impuri” per
la tradizione giudaica. A quel punto il
branco «si precipita dal burrone nel
mare, affogando uno dopo l’altro nel
mare». Il mare (in questo caso il lago:
il linguaggio biblico denomina con un
unico termine le grandi distese d’acqua)
è il simbolo del caos e del male.
La sequenza negativa che regge le fila
del racconto è, dunque, impressionante:
Decapoli, pagani, sepolcri, monti
desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,
porci, mare.
Sembra, quindi, di essere in presenza
di una sorta di compendio del male
del mondo, del demoniaco che avvelena
la storia ma anche dell’idolatria,
perché Isaia descrive così gli idolatri:
«Abitano nei sepolcri, passano la notte
in nascondigli, mangiano carne suina e
cibi impuri... bruciano incenso sui morti
e sui colli insultano il Signore»
(65,4.7). Qual è, allora, il significato da
assegnare a questa narrazione, sia nella
sua realtà storica sia nel suo valore
esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto
dall’evangelista, di quello sventurato,
lo delinea come un pazzo furioso:
non si può legarlo perché reagisce brutalmente,
è autolesionista perché si percuote
con pietre, urla in modo sconclusionato
giorno e notte. Una volta sanato
da Gesù è, invece, tratteggiato come
«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).
Fin qui per quanto riguarda l’evento
storico, ossia la guarigione di un malato
mentale, così come Gesù sanerà un
ragazzo epilettico, scendendo dal monte
della Trasfigurazione (9,14-29). Ma
qual è il valore ulteriore che l’evangelista
assegna a questo fatto? La risposta
deve tener conto proprio di tutti gli elementi
negativi che abbiamo prima elencato
e dell’antica convinzione di Israele,
secondo cui le sindromi più gravi
presupponevano una colpa personale
o una possessione demoniaca. La vicenda,
allora, diventa una narrazione
esemplare per celebrare la vittoria di
Cristo sul male in tutte le sue forme:
egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio
del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle
forze oscure, sia fisiche sia morali, che
tormentano la storia umana.
Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)
17
set
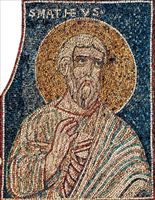
San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.
"Per quelli che
sono fuori tutto
avvienein parabole
affinchéguardino, sì,
ma non vedano,
ascoltino, sì, ma non
comprendano..."
(Marco 4,11-12)
«Così che non si convertano e
venga loro perdonato!»: finisce
con questa fosca clausola
la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo
di Marco riguardo alla funzione delle
parabole che egli sta raccontando. Paradossale
è proprio questa definizione
della finalità delle parabole, espressa
con quell’“affinché” che indica appunto
uno scopo da raggiungere. Forse che
Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,
che è anche il suo modo più comune
di insegnare, per offuscare la
mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli
la conversione («così che non si
convertano») e il relativo perdono dei
peccati («e non venga loro perdonato»)?
La frase, in verità, si basa su una citazione
del profeta Isaia che, nel giorno della
sua vocazione, aveva ricevuto questo
monito: «Rendi insensibile il cuore di
questo popolo, rendilo duro d’orecchi e
acceca i loro occhi, e non veda con gli
occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda
col cuore, né si converta così da
essere guarito!» (6,10).
Dobbiamo proprio partire da questa
citazione per comprendere le dure parole
di Cristo che sembrerebbero smentire
la finalità salvifica della sua predicazione.
È chiaro il contenuto dell’appello rivolto
a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto
degli Israeliti, un fenomeno scontato
e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi
sono in realtà equivalenti a indicativi:
si adotta questa forma per
mostrare quale sarà il risultato della
predicazione profetica, che Dio certamente
non vuole, ma che gli è già nota
ed è inserita nel suo disegno di salvezza.
Questo progetto salvifico, però, continuerà
lo stesso e si attuerà giudicando il peccato
e l’indurimento del cuore e salvando
chi si convertirà e compirà il bene.
L’imperativo non è, quindi, un invito
a operare in quella linea negativa, bensì
è un modo per rappresentare in forma
efficace che neanche il male sfugge
al piano divino, che non esiste una divinità
negativa che si oppone all’unico Signore,
come insegnava il dualismo religioso
(Dio del bene contro il dio del male),
che la libertà umana con le sue scelte
perverse non è ignota al Creatore e
non frustra la sua volontà di salvezza.
Nello stesso libro di Isaia si giunge al
punto di porre anche il male sotto il comando
divino: «Sono io che formo la luce
e le tenebre, faccio il bene e provoco
il male» (45,7). Con questa frase così
aspra si vuole soltanto ricordare che
nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;
anche il male e il peccato possono
essere inquadrati nel suo grande disegno
sull’essere e sull’esistere.
Gesù cita, dunque, questa tesi importante
formulata nello scritto isaiano e
quella “finalità” («affinché...») è di tipo
“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale
espressione «affinché si adempia
la Scrittura che dice...». L’evangelista
ne condivide con Gesù (che rimanda
a Isaia) il contenuto: le parabole,
che dovrebbero essere un luminoso
esempio di rivelazione, diventano un
elemento di ostinazione contro Cristo.
Questo, però, non deve impressionare,
perché Dio – che sa anche dal male trarre
un bene – continuerà lo stesso a compiere
l’insediamento del suo Regno.
È interessante vedere come Matteo
abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù
sostituendo alla finale («affinché...»)
una causale più immediata e chiara
(«perché...»). Il messaggio in parabole di
Gesù non è accolto «perché il cuore di
questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri d’orecchi, hanno
chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).
Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)
10
set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.
"Nella sinagoga
vi era un uomo
posseduto da uno
spirito impuro.
Cominciò
a gridare:
«Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno?
Io so chi tu sei:
il Santo di Dio!»"
(Marco 1,23-24)
Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:
nell’arco di un giorno e nello
spazio di questa cittadina che s’affaccia
sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie
di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge
nella sinagoga locale (quella che Giovanni
inserì come fondale per il celebre discorso
di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso
una persona si alza nell’assemblea, mentre
Gesù sta insegnando con grande autorità, e
gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo
(Marco 1,21-26). Chi travolge
quest’uomo apparentemente normale, facendone
un avversario di Cristo?
In lui agisce un’inattesa presenza specifica,
sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È
una presenza vitale e personale che interloquisce
con Cristo, paradossalmente riconoscendolo
come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come
dotata di una trascendenza e di un’origine
divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il
quale sa di avere come avversario Dio stesso,
presente e operante in Gesù Cristo. Non
possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione
da una malattia grave, come la demenza (Marco
5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito
considereremo e rubricati dagli evangelisti
come possessioni diaboliche.
Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino
Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna
del demoniaco tutto il negativo della storia:
le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli
influssi sociali nefasti, il peccato personale, il
male in generale. Qui, invece, si ha una presenza
personale specifica; è l’incontro con un
essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi
suo avversario; con lui Gesù ingaggia
un duello che si risolve con un comando
efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».
E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido
di sconfitta di Satana. La salvezza non viene
da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni
magiche, ma solo da un ordine autorevole
e operativo di Cristo.
Al centro di questo racconto non c’è, quindi,
lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore
dal male. Il cristianesimo rigetta ogni
forma di dualismo che veda come arbitri della
storia e dell’essere due divinità antitetiche: il
demonio non è il principio del male che combatte
il principio divino del bene. Satana (in
ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è
da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,
la sua presenza dev’essere ridimensionata,
il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un
essere personale che agisce con forza. Certo,
l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,
perché si tratta di un concetto positivo,
usato anche per Dio (ad esempio, le tre
“persone” della Trinità).
Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale
l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi
anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe
essere segno di intimità, di donazione, di
amore. Lo scrittore francese agnostico André
Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:
Io sono colui che non sono». E curiosamente
lo stesso autore concludeva: «Non credo nel
diavolo; ma è proprio quello che il diavolo
spera: che non si creda in lui». A lui farà eco
Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima
astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce
della sua morte».
Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)
02
ago

Sacra parentela, dipinto originario della Germania, circa 1500. Philadelphia, Museum of Art.
"Gesù chiese
ai farisei: «Che
cosa pensate
del Cristo?
Di chi è figlio?».
Gli risposero:
«Di Davide»".
(Matteo 22,41-42)
Questa volta non sono i suoi avversari
a punzecchiare Gesù, come
accade ripetutamente nella pagina
del capitolo 22 di Matteo, una pagina
costellata di “controversie”, ossia di
polemiche con farisei e sadducei. Ora è
lui stesso che provoca i farisei riuniti
in un’assemblea, rivolgendo loro il quesito
che abbiamo citato, apparentemente
banale. Non era, infatti, noto a
tutti i lettori della Bibbia che il Messia
sarebbe disceso dal filo genealogico davidico?
Ricordiamo che la parola “Cristo”
è la versione greca dell’ebraico
“Messia” (Mashiah) che significa “consacrato”,
e che “figlio” è usato spesso in
senso lato per indicare un discendente.
Dov’è, dunque, la difficoltà?
Essa è da cercare nel prosieguo della
discussione. Gesù, infatti, mette sul tappeto
del dibattito un celebre Salmo messianico,
il 110, ritenuto opera di Davide
come si evince dal titolo che gli era stato
apposto: «Di Davide. Salmo». L’inno,
composto dal famoso sovrano considerato
appunto dalla tradizione come
l’antenato del Messia, «mosso dallo Spirito
» (22,43), inizia con un oracolo divino
che è così introdotto: «Disse il Signore
[Yhwh Dio] al mio Signore [il re Messia]
». Segue l’oracolo: «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici sotto
i tuoi piedi». Davide, quindi, chiama il
Messia «mio signore». Facile è l’obiezione
di Cristo: «Se dunque lo chiama “Signore”
come può essere suo figlio?»
(22,44-45). Se il Messia-Cristo è “figlio
di Davide”, come può Davide definirlo
suo “Signore” e quindi a lui superiore?
I farisei si trovano impastoiati in
una disputa di taglio rabbinico, un genere
nel quale peraltro eccellevano.
Gesù li avviluppa nella stessa rete che essi
più di una volta avevano teso contro
di lui con i loro quesiti. A questo punto,
però, ci si attenderebbe di vedere come
Gesù – qui raffigurato nella veste di un
rabbí giudaico – riesca a risolvere la contraddizione
tra un Messia contemporaneamente
figlio e Signore di Davide, secondo
l’analisi appena fatta del Salmo
110. La conclusione di Matteo è spiazzante:
«Nessuno era in grado di rispondergli
e, da quel giorno, nessuno osò
più interrogarlo» (22,46). Marco, che ambienta
questa scena nell’area del tempio
di Gerusalemme, senza introdurre i
farisei come interlocutori, conclude semplicemente:
«la folla numerosa lo ascoltava
volentieri» (12,37).
La risposta a quell’apparente contraddizione
è ovviamente possibile solo
in sede cristiana. Per il giudaismo,
infatti, il Messia rimane creatura umana
e come tale non potrà essere definito
“Signore”. Nel cristianesimo il Cristo
ha certamente una reale dimensione
storica e, quindi, è ancorato nella
sua umanità a una discendenza, quella
davidica, attestata dalla genealogia
che lo stesso Matteo pone in apertura
al suo Vangelo: «Genealogia di Gesù
Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo
» (1,1). Egli è, dunque, realmente «figlio
[discendente] di Davide», legato alla
linea della promessa messianica
(2Samuele 7; Salmo 89). Ma contemporaneamente
è figlio di Dio e, in questa
luce, è “Signore” di Davide. Il mistero
centrale del cristiano, l’Incarnazione,
risolve dunque anche l’enigma del Salmo
110, posto da Gesù all’attenzione
dei farisei.
Pubblicato il 02 agosto 2012 - Commenti (2)
19
lug

Francesco Traini (secolo XIV), Giudizio finale, particolare con angelo e beato. Pisa, Camposanto.
"Amico, come mai
sei entrato qui senza
l’abito nuziale?...
Legatelo mani e piedi
e gettatelo fuori
nelle tenebre!"
(Matteo 16,23)
Le varie parabole di Gesù attingono
sempre alla vita sociale di un popolo.
Nel caso del banchetto nuziale
regale (Matteo 22,1-14) si fa riferimento
a un evento che, anche ai nostri giorni,
stimola l’interesse della comunicazione
e la curiosità della gente. Gesù, elaborando
un simile avvenimento, lo colora
di allusioni allegoriche modulate anche
sulla tradizione biblica: il re evoca
Dio, mentre suo figlio si trasfigura nel
Messia e il banchetto nuziale diventa
la grande celebrazione della festosa
era messianica (si legga Isaia 25,6-10);
nei servi inviati a convocare gli invitati
sono riconoscibili i profeti e gli apostoli;
gli invitati della prima cernita che si
comportano in modo così altezzoso e
fin aggressivo incarnano l’Israele peccatore
e i Giudei che rigettano Cristo; i
chiamati raccolti per le strade rimandano
ai pagani lieti di essere ammessi in
quel banchetto privilegiato, mentre la
città dei ribelli data alle fiamme è l’anticipazione
della rovina di Gerusalemme
del 70 dopo Cristo.
Rimane, però, un’altra scena piuttosto
sconcertante, introdotta solo da Matteo.
Alcuni studiosi pensano persino
che si tratti di un’altra parabola “incollata”
a quella del banchetto nuziale che è
nota anche a Luca (14,16-24). La prospettiva
sembra diversa e più universale:
siamo di fronte al giudizio finale ove
si consumerà una divisione netta, simile
a quella tra grano e zizzania di un’altra
nota parabola matteana (13,24-30).
È da questa seconda parte del racconto
che noi abbiamo desunto l’elemento
centrale piuttosto sconcertante, che vede
come protagonista un uomo senza
l’abito da cerimonia.
La perplessità che proviamo è spontanea:
una condanna così aspra è giustificata
da una semplice mancanza di etichetta?
Evidentemente no. Bisogna risalire
al simbolismo, diffuso in tutte le
culture, della veste. Essa non ha solo
funzioni concrete nei confronti del clima
o di decenza riguardo al pubblico,
ma rivela anche un aspetto emblematico,
estetico e sociale (si pensi solo alla
funzione fin esasperata della moda ai
nostri giorni). Anzi, l’abito da cerimonia
è spesso indizio di una dignità civile
o religiosa: è ciò che accade per i paramenti
sacerdotali, la corona e lo scettro
reale, la fascia del sindaco e così
via, tant’è vero che per indicare l’accesso
a una carica pubblica parliamo di
“investitura”.
È chiaro, allora, che l’assenza di abito
nuziale nel protagonista di questo secondo
racconto è indizio ben più grave di
una semplice carenza di educazione. È la
privazione di quelle opere e qualità
morali che possono ammettere al Regno
di Dio e al suo banchetto. Non è
sufficiente la vocazione a un compito (“i
chiamati”), bisogna anche adempierlo
con fedeltà e impegno così da diventare
“eletti”, cioè ammessi alla festa finale.
Fede e opere di giustizia devono unirsi
nell’esistenza, perché «non chiunque
dice: “Signore, Signore!” entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre che è nei cieli» (Matteo 7,21).
Altrimenti si è votati alle tenebre della
condanna infernale, lontani dal banchetto
del Regno di Dio. Là si avrà «pianto e
stridore di denti», un’immagine quest’ultima
non solo di freddo, come si ha nel
mondo classico e come suppone l’oscurità
con l’assenza del sole, ma anche di terrore
e di disperazione.
Pubblicato il 19 luglio 2012 - Commenti (2)
09
lug

Dromedario utilizzato come mezzo di trasporto. Incisione tratta da "La Terre Illustree" n. 73, 24 marzo 1892. Tunisia.
"È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago che
un ricco entri nel regno di Dio".
(Matteo 19,24)
Il detto di Gesù, strettamente parlando, non risulta né strano né di ardua interpretazione a chi conosce il linguaggio dell'antico Vicino Oriente che ama il paradosso, i colori accesi, le tonalità forti. È stata solo la sensibilità occidentale a tentarne un ridimensionamento secondo una logica più "normale". Così c'è chi ha voluto ricondurre il greco kámêlon, "cammello" a un kámilon (la ê e la i avevano in passato e hanno oggi nel greco moderno lo stesso suono – i – nella pronuncia), che era invece una sorta di gomena o nodo marinaio: in questo modo si renderebbe meno eccessiva e più coerente l'immagine. C'è chi è ricorso fantasiosamente a una non documentata e, quindi, ipotetica porta di Gerusalemme denominata "cruna dell'ago" a causa della sua piccolezza e ristrettezza, sulla scia della "porta stretta" – evidentemente metaforica – evocata da Gesù nel Discorso della Montagna (Matteo 7,13).
In realtà, si deve lasciare il paragone in tutta la sua forza paradossale: la ricchezza è un ostacolo invalicabile per entrare nel regno di Dio che è destinato ai «poveri in spirito» e – come abbiamo visto in una precedente nostra analisi – costoro non sono tali per un vago distacco "spirituale" dai loro beni, ma perché essi sono radicalmente e totalmente liberi dall'idolatria delle cose e del loro possesso. Tra l'altro, che questo senso forte sia inteso da Gesù emerge dalla successiva reazione dei discepoli sconcertati (in greco si ha exepléssonto sfódra, cioè "furono grandemente stupiti, costernati"). E Cristo lo conferma dichiarando che la salvezza del ricco è sostanzialmente possibile solo attraverso un miracolo: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile!» (19,26).
Che il significato dell'immagine sia quello del contrasto estremo tra la microscopica cruna dell'ago e il mastodontico cammello è confermato anche da altri due paralleli esterni. Il primo è nello stesso Vangelo di Matteo, all'interno della veemente sequenza di sette "Guai!" che Gesù scaglia contro gli scribi e i farisei, rivelando che – se l'ira è un vizio capitale – lo sdegno in difesa della virtù e del bene è una virtù. Là si legge: «Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!» (23,24). È evidente l'implicito nesso tra questo poderoso animale e i piccoli fori del colino.
La seconda conferma viene da un testo rabbinico posteriore a Gesù, nel quale si delinea l'impossibilità e l'assurdità del far passare anche un elefante per la cruna di un ago! Cristo rivela, così, non solo la ferma condanna della ricchezza egoista che impedisce la sua sequela, come era accaduto al giovane ricco nel cui contesto è collocato il nostro detto (19,16-22), ma mostra anche la sua aderenza al linguaggio colorito della cultura in cui egli era incarnato.
In appendice ricordiamo che il cammello – in ebraico gamal, termine che vale anche per il dromedario a una sola gobba – è menzionato nella Bibbia a partire già dai patriarchi (ad esempio, Genesi 24,10-67 e 31,17.34). Curiosamente notiamo che, secoli dopo, secondo un registro riferito dal libro biblico di Esdra (2,66-67), gli Ebrei rimpatriati dall'esilio a Babilonia avevano una dotazione di ben 435 cammelli, molto più dei 245 muli, ma ovviamente meno dei più semplici asini che erano 6.720 e dei 736 cavalli. Nel Nuovo Testamento Giovanni Battista indossava abiti tessuti con peli di cammello (Matteo 3,4), mentre nella tradizione popolare beduina l'urina di cammella è considerata, a livello di cosmesi femminile, una sorta di "acqua di colonia"...!
Pubblicato il 09 luglio 2012 - Commenti (2)
21
giu

Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553), Donna sorpresa in adulterio, 1532. Budapest, Museo di Belle Arti.
"Io vi dico: chiunque
ripudia la propria moglie,
se non in caso di pornéia,
e ne sposa un’altra,
commette adulterio".
(Matteo 19,9)
Eccoci di fronte a un passo che ha suscitato una valanga di interpretazioni e commenti e che ha creato una divaricazione persino all’interno delle stesse Chiese cristiane. Facciamo
subito due premesse. La prima è estrinseca. Il testo ricorre anche in una delle sei “antitesi” che Matteo colloca nel Discorso della Montagna. In esse si illustra non tanto il superamento, ma la pienezza che Cristo vuole far emergere dal dettato biblico. Sul ripudio matrimoniale egli affermava, citando il versetto del Deuteronomio (24,1) sul divorzio: «Fu detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie – eccetto il caso di pornéia – la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio» (5,32).
La seconda premessa riguarda il contesto del nostro passo (19,1-9). In esso Gesù, provocato dai suoi interlocutori che lo volevano mettere in contraddizione con la norma sulla liceità
del divorzio «per una qualsiasi mancanza», come si affermava nel Deuteronomio, risale alla Genesi che dichiara l’uomo e la donna destinati a diventare «una sola carne» (2,24). Questo è il progetto divino sulla coppia al quale Cristo si allinea, per cui «l’uomo non deve dividere ciò che Dio ha congiunto» (Matteo 19,6). Quella del Deuteronomio è, dunque, un’eccezione concessa «per la durezza del vostro cuore» (19,8). Gesù, quindi, propone nella sua visione del matrimonio il modello dell’indissolubilità.
Ma a questo punto come spiegare l’inciso – da noi lasciato con il termine greco pornéia – che presenta un’eccezione? È probabile che qui si sia di fronte a un elemento redazionale introdotto da Matteo per giustificare una prassi in vigore nella comunità giudeo-cristiana delle origini. Sarebbe, quindi, una sorta di norma ecclesiale locale che veniva incontro alla domanda rabbinica sull’interpretazione della clausola del Deuteronomio concernente il caso del divorzio «per una qualsiasi mancanza». Nell’ebraismo si confrontavano due scuole teologiche, l’una più “liberale”, incline a concedere un largo raggio di casi di divorzio (rabbí Hillel), un’altra più restrittiva e orientata ad ammettere solo l’adulterio come giustificazione per il divorzio.
Quale sarebbe, allora, l’eccezione riconosciuta dalla Chiesa giudeo-cristiana ed espressa con il vocabolo greco pornéia? Non può essere, come si traduceva in passato, il “concubinato” non essendo esso un matrimonio in senso autentico, né una generica “fornicazione”, cioè l’adulterio, perché in questo caso si sarebbe usato il termine proprio moichéia. Tra l’altro, è interessante notare che alcune opere dei primi tempi
cristiani – come Il pastore di Erma (IV,1,4-8) – e autori come Clemente di Alessandria (Stromata 2,23) dichiarano che il marito che lascia la sposa adultera non può risposarsi perché permane il precedente legame matrimoniale.
Nel giudaismo del tempo esisteva un termine, zenût, equivalente alla pornéia matteana (“prostituzione”) che indicava tecnicamente le unioni illegittime come quella tra un uomo e la sua matrigna, condannata già dal libro biblico del Levitico (18,8;20,11) e dallo stesso san Paolo (1Corinzi 5,1). In pratica, anche se non era in uso allora questa fattispecie giuridica, si tratterebbe di una dichiarazione di nullità del matrimonio contratto, linea seguita dalla Chiesa cattolica sui casi di nullità del vincolo matrimoniale precedente. Sappiamo, però, che le Chiese ortodosse e protestanti hanno interpretato l’eccezione della pornéia come adulterio e, perciò, hanno ammesso il divorzio, sia pure limitandolo a questo caso. In realtà, la visione di Cristo sul matrimonio era netta e radicale, nello spirito di una cosciente, piena e indissolubile donazione reciproca.
Pubblicato il 21 giugno 2012 - Commenti (3)
14
giu

Albrecht Altdorfer (1480-1538), Martirio di san Floriano. Firenze, Galleria degli Uffizi.
"Chi scandalizzerà
uno solo di questi
piccoli che credono
in me, gli conviene
che gli venga appesa
al collo una macina
da mulino e sia
gettato nel profondo
del mare".
(Matteo 18,6)
Spesso questa frase è stata addotta per condannare i pedofili e persino per giustificarne la condanna a morte. Come può il “mite” Gesù che insegna il perdono, pur condannando la colpa, giungere a questo punto di crudeltà? Per interpretare correttamente il testo dobbiamo procedere per gradi. Innanzitutto puntiamo al soggetto coinvolto nello “scandalo”, termine che, come è noto, indica letteralmente il far “inciampare” uno e farlo cadere a terra, simbolo anche della tentazione perversa. Nell’originale greco non si parla di “bambini” (paidía), bensì di “piccoli” (mikroí), una categoria non anagrafica ma esistenziale, tant’è vero che subito dopo è specificata con la frase «che credono in me». Ferma restando la condanna che noi dobbiamo assegnare all’infamia della pedofilia, la questione qui trattata da Gesù è differente: di scena sono coloro che sono deboli nella fede, “piccoli” nel credere, che devono ancora crescere e che possono essere facilmente scandalizzati dal nostro cattivo esempio di “maturi” e “adulti” nella fede. Anche san Paolo ammonisce i cristiani di Roma a saper «accogliere chi fra di voi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni» (14,1). Cristo, dunque, condanna con durezza chi mette consapevolmente in crisi il fratello “piccolo” nella fede.
E lo fa ricorrendo a un simbolo di giudizio severissimo, il cosiddetto katapontismós praticato dai Romani, ossia l’esecuzione dei colpevoli per annegamento, attestata dagli storici Svetonio e Giuseppe Flavio. Ora, per tirare le fila sul valore generale di questo passo veemente, è necessario ricordare che il linguaggio semitico, usato anche da Gesù, ama i colori accesi, soprattutto nel caso di maledizioni, cioè di invocazioni del giudizio divino nei confronti delle colpe gravi. Pertanto, quel Gesù – che ha insegnato appunto l’amore e il perdono – non può certo suggerire una simile macabra esecuzione capitale o il suicidio del peccatore. Egli, però, non si astiene dal denunciare il male e ricorre a un’immagine terribile, destinata a far comprendere la gravità della colpa di chi scandalizza il fratello dalla fede fragile. È un modo simbolico e vigoroso, tipico del linguaggio orientale dalle tinte forti, per ricordare il severo giudizio divino riguardo aquel peccato. L’immagine del legare al collo la pesante macina, con un foro destinato a contenere la barra che l’asino avrebbe fatto ruotare, diventa un segno della severa condanna che incombe sullo scandalizzatore, segno che noi potremmo riutilizzare per altri giudizi su colpe gravi, sempre tenendo conto delle premesse interpretative sopra fatte. Come scrive un commentatore dei Vangeli, Simon Légasse, «la terribile sorte dell’annegato con la mola al collo è poca cosa in confronto a ciò che attende nel giudizio ultimo di Dio colui che ha provocato lo scandalo».
Pubblicato il 14 giugno 2012 - Commenti (2)
07
giu

Il profeta Elia, mosaico absidale. Ravenna, Sant'Apollinare in Classe.
"Verrà Elia e ristabilirà
ogni cosa.
Ma io vi dico: Elia è già
venuto e non l'hanno
riconosciuto."
(Matteo 17, 11-12)
Questa frase di Gesù è una risposta a un quesito di Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre stanno scendendo dal monte della Trasfigurazione: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». Per spiegarel’enigma di quel “prima” e di questo ritorno del profeta Elia sulla scena del mondo, dobbiamo risalire alla fonte che aveva generato questa credenza sostenuta dagli scribi giudaici di quel tempo. Essa è da identificare in una frase del profeta Malachia nella quale Dio dichiarava: «Io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (3,23). A sua volta, questa evidente base biblica dell’affermazione degli scribi ha la sua matrice nel racconto della fine di Elia, assunto in cielo per una piena comunione con Dio (2Re 2,1-13).
Era sorta, così, la convinzione che il profeta, vivente per sempre presso Dio dopo la sua ascensione al cielo, sarebbe ritornato ad annunciare al mondo la venuta del Messia e il giudizio finale. Non mancherà nella tradizione successiva ebraica, cristiana e musulmana – di stampo, però, esoterico e fin eterodosso – chi affermasse la sua reincarnazione, dottrina in verità aliena all’antropologia biblica che, invece, proclama la risurrezione. La tesi del ritorno di Elia, vivacemente sostenuta da certi testi apocrifi giudaici come il Libro di Enok, ha lasciato tracce nel rituale ebraico della circoncisione, durante la quale si lascia libera la cosiddetta “sedia di Elia” nella speranza che egli si renda presente.
Nella cena pasquale si ha il “calice di Elia”, tenuto colmo sperando che egli venga a comunicare l’arrivo del Messia attraverso la porta di casa lasciata socchiusa. Si riteneva anche, a livello popolare, che Elia venisse costantemente sulla terra, senza essere riconosciuto, a sostenere i poveri, i malati e i moribondi. Si spiega, così, il fatto che, quando Gesù in croce grida l’avvio del Salmo 22 in aramaico ’Elî, ’Elî, lemâ sabachtanî («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»), la folla che assiste confonda quell’’Elî, ’Elî come un’invocazione rivolta al profeta protettore dei moribondi: «Alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia!”... Gli altri dicevano: “Vediamo se viene Elia a salvarlo!”» (Matteo 27,47.49).
Con questi antefatti è facile comprendere la risposta di Gesù ai suoi apostoli: «Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno voluto». Cristo si proclama, dunque, come Messia e dichiara che il suo Elia annunziatore fu Giovanni Battista. Ma la gente non lo riconobbe come precursore del Messia Gesù e lo condannò al martirio. L’evangelista Matteo alla fine esplicita questa interpretazione aggiungendo: «Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista» (17,13). Già in un’altra occasione, dopo aver tessuto l’elogio del Battista, Gesù aveva ribadito questa identificazione simbolica: «Se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire» (11,14).
Pubblicato il 07 giugno 2012 - Commenti (1)
31
mag

San Pietro, mosaico della cupola. Ravenna, Battistero degli Ariani.
"Gesù, voltandosi,
disse a Pietro:
«Va’ dietro a me,
Satana! Tu mi sei
di scandalo...».".
(Matteo 16,23)
Potrà stupire questa versione del celebre monito che Gesù rivolge a Pietro, dopo avergli assegnato il primato tra gli apostoli attraverso i simboli della pietra, delle chiavi e del potere di “legare e sciogliere” (Matteo 16,13-20). Siamo, infatti, abituati al più forte: «Lungi da me, Satana!». L’apostolo aveva reagito in maniera veemente quando Gesù aveva fatto balenare il destino che lo attendeva a Gerusalemme nell’abisso di dolore e di morte della passione: «Signore, questo non ti deve accadere mai!». E Cristo gli aveva opposto un rifiuto netto.
Sarebbe più logico, perciò, pensare a una sorta di rigetto di Pietro che – dopo la sua “confessione” del «Cristo Figlio del Dio vivente», che gli aveva meritato una beatitudine da parte di Gesù – verrebbe “sconfessato” dal suo Signore e definito uno “scandalo”. Il vocabolo in greco indica la pietra che fa inciampare e, quindi, non più la pietra di fondazione della Chiesa, come Gesù gli aveva prima annunciato. A questa resa più dura condurrebbe anche la frase successiva: «Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini», per non parlare poi del brutale appellativo usato da Gesù, “Satana”, termine di matrice ebraica che significa “avversario, accusatore”, e che rende Pietro non più l’apostolo delegato a rappresentare Cristo nella storia, ma quasi il suo antagonista.
Come si spiega, allora, questa traduzione più edulcorata che troviamo nel nuovo lezionario liturgico? In realtà, essa è fedele all’originale greco hýpaghe opíso mou, “seguimi dietro a me”. È in pratica il tradizionale Vade retro latino che è corretto, ma che noi abbiamo di solito inteso appunto come una reiezione che subentra all’elezione di Pietro. Qual è, invece, il vero significato del monito di Cristo? La risposta è semplice ed è precisata dalla frase successiva di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro a me (opíso mou elthéin), rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua» (16,24).
Pietro abbandoni, dunque, la sua illusoria concezione di un messianismo fatto solo di gloria e di successo, e si metta umilmente dietro al suo Signore, salendo la strada erta e irta di prove del Golgota. È questo il vero discepolato, altrimenti si è avversari “satanici” di Cristo. La via della croce comincia, perciò, già in quel momento e Pietro è invitato a essere il seguace del suo Maestro, “andando dietro a lui”, pronto anche a «perdere la propria vita per causa mia», come dirà ancora Gesù, così da “trovarla” in un altro modo più alto e intenso.
Questo appello era già stato anticipato da Cristo nel “discorso missionario” rivolto ai suoi discepoli precedentemente: «Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me» (Matteo 10,38). E Pietro testimonierà di aver imparato la lezione della croce, quando si avvierà al martirio che, secondo la tradizione, avvenne per crocifissione. Alcuni pensano che un’allusione a questa meta del discepolato e della stessa vita di Pietro sia nella frase che il Risorto gli rivolge sul lago di Tiberiade, dopo avergli rinnovato la missione di “pascere le pecore” del gregge di Cristo: «Quando sarai vecchio stenderai le tue mani...»; e l’evangelista Giovanni commenta: «Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio» (21,18-19).
Pubblicato il 31 maggio 2012 - Commenti (2)
24
mag

L’ultima cena, vetrata. St. Mary’s Church, Norfolk (Inghilterra).
"Fate attenzione: guardatevi dal
lievito dei farisei e dei sadducei!".
(Matteo 16,6.12)
Gesù è in barca sul lago di Tiberiade con i suoi
discepoli ed essi s’accorgono di non avere pane
a bordo. Cristo dissolve la loro preoccupazione
ricordando le due precedenti moltiplicazioni
dei pani (16,5-12), ma sposta il discorso dalla dimensione
materiale a quella più spirituale, ricorrendo al
simbolo del lievito. La frase è polemica nei confronti
dei due tradizionali gruppi religiosi e politici del giudaismo.
Da un lato, i farisei, in aramaico “i separati”
o forse anche “i separatori”, cioè coloro che sapevano
distinguere i precetti della Legge biblica secondo il loro
maggiore o minore rilievo. Di per sé essi incarnavano
un’ideologia aperta, spirituale e “laica”. I Vangeli
polemizzano con loro più per l’ipocrisia e l’incoerenza
dei loro atteggiamenti che non per i contenuti
della loro dottrina che era abbastanza vicina almeno
ad alcuni insegnamenti di Gesù.
Gesù è in barca sul lago di Tiberiade con i suoi
discepoli ed essi s’accorgono di non avere pane
a bordo. Cristo dissolve la loro preoccupazione
ricordando le due precedenti moltiplicazioni
dei pani (16,5-12), ma sposta il discorso dalla dimensione
materiale a quella più spirituale, ricorrendo al
simbolo del lievito. La frase è polemica nei confronti
dei due tradizionali gruppi religiosi e politici del giudaismo.
Da un lato, i farisei, in aramaico “i separati”
o forse anche “i separatori”, cioè coloro che sapevano
distinguere i precetti della Legge biblica secondo il loro
maggiore o minore rilievo. Di per sé essi incarnavano
un’ideologia aperta, spirituale e “laica”. I Vangeli
polemizzano con loro più per l’ipocrisia e l’incoerenza
dei loro atteggiamenti che non per i contenuti
della loro dottrina che era abbastanza vicina almeno
ad alcuni insegnamenti di Gesù.
Dominante, però, è l’accezione negativa perché il
lievito, facendo fermentare la massa, ne induce anche
la corruzione, tant’è vero che per la celebrazione
della pasqua ebraica era di rigore il pane “azzimo”,
termine di origine greca che significa “non lievitato”
(in ebraico mazzôt). L’origine era da cercare nell’uso
nomadico di cuocere il pane su lastre di pietra riscaldate:
non per nulla la pasqua aveva una genesi di tipo
pastorale-nomadico. Ma l’aspetto pratico si era trasformato
in una componente rituale: nel seder pasquale
giudaico, cioè nell’ordine dei riti della cena,
c’è anche la ricerca e l’eliminazione di ogni frammento
di pane lievitato presente in casa, perché non contamini
la purezza incorruttibile del pane azzimo. A questa
prassi si è adattata la liturgia eucaristica con l’uso
dell’ostia azzima.
È facile, allora, comprendere il significato delle parole
di Gesù: l’insegnamento e il comportamento
dei farisei e dei sadducei sono principio di perversione
della comunità che li segue e i discepoli devono
vigilare per evitarne la contaminazione. Fuor di
metafora, Gesù aveva già ammonito: «Lasciateli stare!
Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida
un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!» (Matteo
15,14). San Paolo, evocando proprio la celebrazione
pasquale, espliciterà a livello morale ed esistenziale
generale il simbolismo: «Non sapete che un po’ di
lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito
vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azzimi.
Infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo,
dunque, la festa non con il lievito vecchio, né
con lievito di malizia e perversione, ma con azzimi di
sincerità e verità» (1Corinzi 5,6-8).
Pubblicato il 24 maggio 2012 - Commenti (2)
17
mag

Alessandro Allori detto il Bronzino (1535-1607), Cristo e la cananea. Firenze, San Giovannino degli Scolopi.
"Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini!".
(Matteo 15,26)
Scena piuttosto inattesa, questa, descritta solo da Matteo (15,21-28) e Marco (7,24-30): essa presenta un Gesù molto duro, ai limiti dell’insensibilità, a tal punto che gli stessi discepoli devono intervenire, almeno per placare la donna che li sta seguendo e che reca con sé il suo dramma. Cristo si trova nel territorio di frontiera con l’attuale Libano e un’indigena cananea (o siro-fenicia) si aggrappa a lui, sulla base della sua fama di guaritore, implorando un suo intervento per la figlia malata.
Gesù all’inizio la ignora semplicemente («non le rivolse neppure una parola»). All’intercessione dei discepoli che vogliono liberarsi di questa presenza importuna, reagisce con un gelido “no”: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», ribadendo il primato dell’orizzonte ebraico nella sua missione, sulla scia dell’elezione di Israele. Ma la sua freddezza, sia pure motivata, non scoraggia la donna che gli urla: «Signore, aiutami!». E qui il nostro sconcerto raggiunge l’apice, sentendo Gesù replicarle in modo sferzante con un probabile proverbio quasi “razzista”: ai cani non si dà il pane destinato agli esseri umani!
È vero che nella frase si adotta il diminutivo più attenuato, kynária, “cagnolini”, ma è evidente l’appellativo spregiativo di “cani” riservato agli infedeli, cioè ai pagani, a causa della loro impurità religiosa e rituale, tipica di questi animali che già nell’Antico Testamento venivano usati come appellativo offensivo (“cani”) nei confronti dei prostituti maschi, presenti nei culti idolatrici. Ma quando il cuore di una madre soffre per la sua creatura, non conosce offese o limiti, e la sua replica è umile e coraggiosa al tempo stesso: «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
A questo punto Gesù è, per così dire, trasformato dall’esempio della donna straniera; potremmo quasi dire che riceve da lei una lezione di fede che egli esplicita, prima di concederle il dono tanto sospirato: «Donna, grande è la tua fede!». La confessione e la lode rivolte a questa madre pagana aprono idealmente le frontiere della salvezza oltre il popolo ebraico. L’unico requisito decisivo non è più l’etnia o la cultura ma la fede, come era accaduto anche nel caso del centurione romano che implorava a Gesù la guarigione di un suo servo: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!» (Matteo 8,10).
Naturalmente questo comportamento di Gesù, da un lato, marca la sua reale umanità legata a una mentalità, a un linguaggio, a una sensibilità, a un’appartenenza. D’altro lato, però, esso dev’esser letto nella traiettoria della storia della salvezza che ha in Israele il punto di partenza. Dio entra in dialogo con l’umanità attraverso un popolo a cui consegna il suo messaggio e l’incarico di essere testimone nel mondo della sua salvezza.
È questo il tema dell’elezione, della promessa, dell’alleanza che lo stesso san Paolo, apostolo dei pagani, riconosce ed esalta (Romani cc. 9-11), criticando con i profeti la riduzione di questa missione da parte degli ebrei solo a privilegio o a motivo di orgoglio nazionalistico. In questa luce il nostro brano dev’essere interpretato riprendendo tra le mani un testo già da noi commentato, quando Gesù si era rivolto ai Dodici invitandoli inizialmente a «non andare fra i pagani... e a rivolgersi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele» (Matteo 10,5-6), ma infine esortandoli a «fare discepoli tutti i popoli» (28,19).
Pubblicato il 17 maggio 2012 - Commenti (2)
10
mag

Gustave Doré (1832-1883), Gesù cammina sulle acque, incisione.
"Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare… I discepoli, sconvolti, urlarono: «È un fantasma!»".
(Matteo 14,25-26)
La celebre scena di Gesù che avanza sulle acque agitate del lago di Tiberiade (detto “mare” secondo il linguaggio biblico) crea un certo imbarazzo nel lettore moderno, anche credente. Sappiamo, infatti, che Cristo evita intenzionalmente i prodigi taumaturgici, rifugge dalle magie spettacolari, teme che lo si scambi per una “star” degli eventi miracolosi, tant’è vero che spesso egli compie le guarigioni in disparte dalla folla, imponendo il silenzio ai beneficiari. E allora, come spiegare questo atto così clamoroso, peraltro riferito non solo da Marco (6,45-52), la fonte primaria di Matteo, ma anche dal più tardo Vangelo di Giovanni (6,16-21)?
La scena si svolge – se stiamo all’originale greco del Vangelo – «alla quarta veglia» della notte, cioè nell’ultima delle quattro fasi in cui essa era divisa, ossia fra le tre e le sei. Abbiamo, quindi, ancora il segno della tenebra, che è nella Bibbia un simbolo negativo. Analogo è il valore del “mare” che, come è noto, nella Sacra Scrittura incarna il caos, il nulla, il male, tant’è vero che il Giovanni dell’Apocalisse, quando s’affaccerà sulla nuova creazione, scoprirà che «il mare non c’era più» (21,1). Similmente il vento tempestoso è emblema di terrore e di distruzione. Tutta la scena è, quindi, all’insegna della negatività.
Gesù si leva solenne su questo orizzonte, che è agli antipodi della terra, della luce, della quiete, quasi come il Creatore agli inizi stessi dell’atto creativo descritto dalla Genesi. Egli, perciò, compie nei confronti dei discepoli una sorta di azione simbolica simile a quelle che i profeti – soprattutto Geremia ed Ezechiele – manifestavano al loro uditorio, accompagnandole con una spiegazione religiosa. Facile è l’equivoco di chi interpreta la scena come un evento magico o preternaturale. È ciò che accade ai discepoli terrorizzati che urlano: «È un fantasma!».
È per questo che, subito dopo, Gesù spazza via la loro sensazione attraverso due frasi illuminanti che decifrano l’atto nel suo significato teologico e non magico o spettacolare. La prima è da scoprire nell’originale e non nella versione che suona così: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (14,27). In realtà, in greco si ha: egó eimi, «Io sono!». Ora, questa è la versione del nome che Dio rivela a Mosè al Sinai: «Io sono colui che sono!» (Esodo 3,14), nome abbreviato già in quell’occasione in «Io sono ». L’espressione, variamente interpretata, ci ricorda comunque che Dio è una persona (“Io”) la quale esiste e opera (il verbo “essere”).
Ebbene, in quel momento Cristo svela ai discepoli con questo atto eccezionale la sua realtà intima, nascosta dal velo della sua umanità. È un po’ quello che accadrà sul monte della Trasfigurazione: egli ora si presenta in una teofania, cioè in un segno rivelatore della sua divinità di Signore del cosmo e della storia. L’altra frase esplicativa è quella rivolta in finale a Pietro: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» (14,31). Per comprendere l’evento del cammino sulle acque – come anche gli stessi miracoli – è necessario un canale di conoscenza ulteriore rispetto a quello dei sensi e della pura e semplice ragione, ossia la via della fede e dell’adesione al mistero divino.
Pubblicato il 10 maggio 2012 - Commenti (2)
|
|